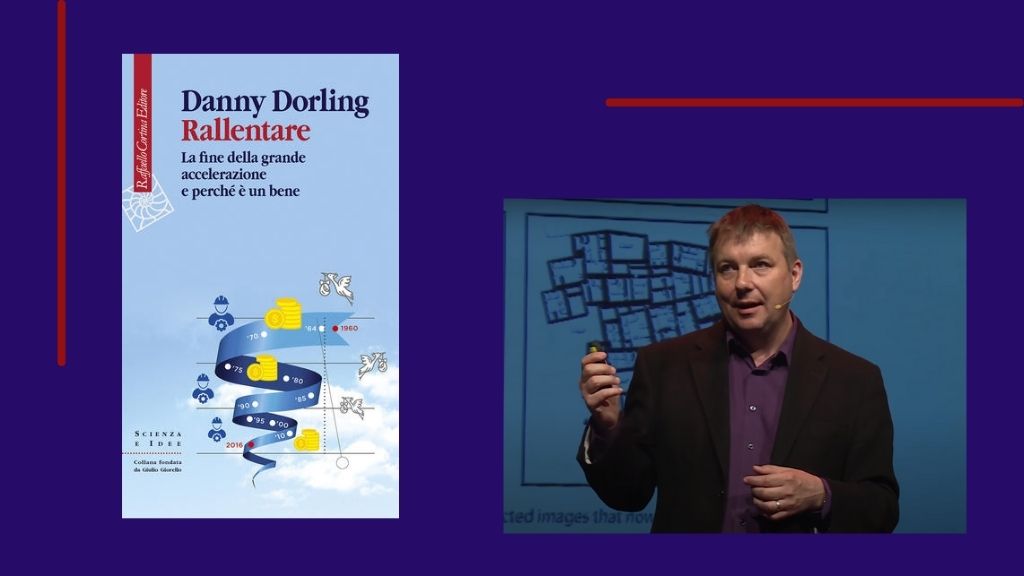Secondo una recente autorevole letteratura scientifica, la Terra, dagli anni 1950, è entrata nel periodo della “Grande accelerazione”: tutti i principali indicatori globali delle attività umane (incremento della popolazione, crescita del PIL, consumo di energia e così via) e tutti quelli che rilevano le variazioni dei maggiori fattori ambientali (biodiversità, ciclo del carbonio e dell’azoto, temperatura di superfice e così via) si espandono esponenzialmente [1]. Tuttavia, non di rado succede nelle indagini scientifiche che il momento della scoperta di un fenomeno coincide con l’inizio del suo declino. Alcuni ricercatori sostengono che, in effetti, la Grande accelerazione appartiene ormai al passato e che sta affermandosi uno Slowdown, un rallentamento generalizzato che spinge le società umane ed il Pianeta verso la stabilizzazione. Tra questi studiosi spicca il geografo britannico Danny Dorling, che ha illustrato e difeso questa tesi in un’ampia monografia, densa di dati empirici [2].
I processi che più robustamente possono supportare l’idea di una progressiva decelerazione sociale riguardano la demografia e la tecnologia. La popolazione è in diminuzione nella maggior parte dei Paesi perché la gente fa pochi figli. Anche in India e Africa sub-sahariana, che erano l’incubo demografico del pianeta, la fertilità sta rallentando ed entro qualche decennio la popolazione comincerà a diminuire. Secondo le previsioni più attendibili, l’umanità si stabilizzerà numericamente entro il 2050, per poi iniziare a contrarsi. Ovviamente, vengono avanzate molteplici spiegazioni del perché la gente fa pochi figli: sul versante delle scelte individuali, le maggiori determinanti sembrano essere l’emancipazione femminile, i migliori livelli d’istruzione, la diffusione dei metodi contraccettivi e l’incertezza intorno alle prospettive occupazionali e reddituali; sul versante collettivo, tenderemo in media a mettere al mondo pochi figli nella consapevolezza che essi ci sopravvivranno e che la società si prender…