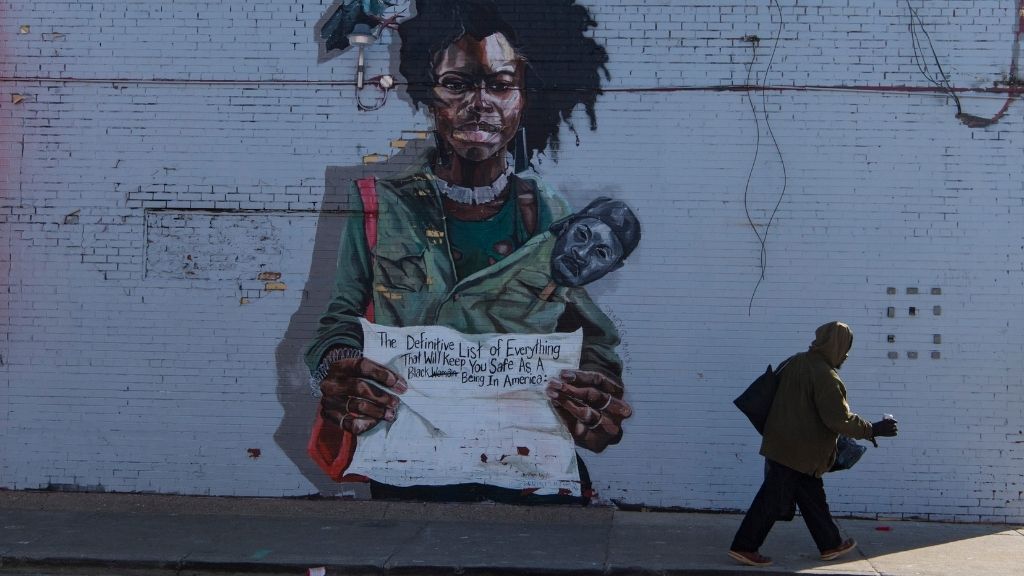Da circa mezzo secolo, le politiche dell’identità rappresentano una delle forme più diffuse di rivendicazione nella «sfera pubblica». Il concetto proposto da Habermas è stato messo nel ripostiglio delle illusioni universaliste borghesi: vi si è opposta, come ha fatto Nancy Fraser, la nozione di “contro-pubblico” oppure lo si è frammentato in tante sfere quanti gruppi, parlando tra l’altro di «sfera pubblica della classe operaia», come se il gruppo o la classe, spesso poco definiti, costituissero un mondo sociale in quanto tale, mentre non sono altro che il prodotto di una relazione con altre entità[1]. L’esaltazione dell’identità di gruppo ha il più delle volte preso la forma di un discorso al mondo globalmente inteso, cosa che ha paradossalmente finito per rafforzare la tesi di Habermas, mentre se ne voleva provare l’inadeguatezza: è su un palcoscenico unico, ampiamente permeato da tradizioni politiche e discorsive della prima potenza culturale del mondo, gli Stati Uniti, che appare ormai l’insieme delle rivendicazioni identitarie. La contraddizione tra l’identificazione di un gruppo come entità collettiva che può essere dotata di uno statuto giuridico, come nel multiculturalismo, e la graduale costituzione di una sfera pubblica globale, che i gruppi prendono come testimone per farsi riconoscere, va di pari passo con la tensione costitutiva che incide sulla nozione di assegnazione. Questa è sempre il prodotto dello sguardo dell’altro, come ha mostrato Frantz Fanon, ispirandosi a Sartre, in Peau noire, masques blancs[2]. Allo stesso tempo, l’assegnazione si traduce nel fissare una definizione del gruppo minoritario che somiglia molto alla rappresentazione nata dallo sguardo dell’altro. Si potrebbe parlare a questo proposito di una astuzia della ragione identitaria.
La rivincita della sovrastruttura
Possiamo uscire da quella che finisce per assomigliare a una trappola? L’identità assegnata, che incontestabilmente è in gran parte il prodotto dell’operazione coloniale, dovrebbe continuare a costituire la base di qualsiasi progetto di emancipazione? Oggi le posizioni sono così polarizzate tra universalisti e identitari che è difficile mettere in piedi un dibattito sereno. Tuttavia, non è inutile abbozzare un altro modo di pensare la questione senza accontentarsi di sterili opposizioni.
Il successo dell’opera di Axel Honneth ha permesso di rimettere al centro dell’attenzione la vecchia nozione hegeliana di riconoscimento[3]. In un contesto segnato dal declino dell’idea, e soprattutto del desiderio, di socialismo, l’insorgere di problematiche relative al riconoscimento è potuto apparire come la sostituzione di una visione della storia fondata sui rapporti di sfruttamento con una sorta di primato del sim…