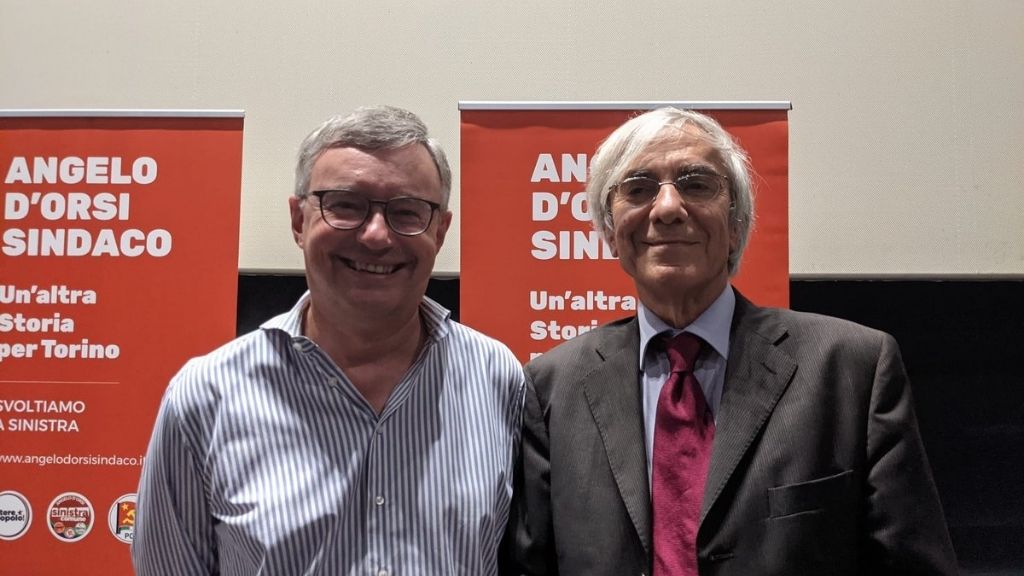Angelo d’Orsi: Spesso si fa molta confusione su alcuni termini che entrano nel lessico del dibattito contemporaneo, storia e memoria per esempio, ma anche storia e politica. A volte gli storici vengono accusati di fare politica attraverso la storia e quindi di non essere oggettivi. Credo invece che la politica abbia un bisogno disperato di storia. Senza un fondamento storico non c’è autentica politica. Abbiamo bisogno di storia per capire la realtà e per fare le nostre proposte di cambiamento. Senza la conoscenza della storia siamo monchi.
Ettore Boffano: Nella presentazione di questo incontro si cita una frase famosa di John Robert Seeley: “La storia è la politica passata, la politica è la storia presente”. A lungo, la storia è stata una ricostruzione della politica che aveva come protagonisti solo i grandi personaggi. Poi, pian piano, tutto è cambiato: nella ricostruzione storica sono entrate finalmente le classi più deboli e tutti coloro che erano state dimenticati nella “grande storia”. Perché, dunque, storia e politica sono così incrociate ed è così importante che si usi la storia per comprendere la politica di oggi?
Alessandro Barbero: Nella cultura occidentale, da quando è stata inventata la storia, da Erodoto in poi, ci si è sempre domandati: di che cosa ci dobbiamo occupare esattamente? Del faraone o delle credenze religiose dei suoi sudditi? Di quello che mangiano, delle loro feste e dei loro riti? Successivamente, nel mondo medievale e soprattutto moderno, c’è stata una deriva verso l’idea che la storia è la storia delle cose che vale la pena di ricordare. E la vita della gente qualunque non vale la pena di ricordarsela, chissenefrega. Vale la pena di ricordare cosa hanno fatto gli imperatori e i papi. E gli imperatori e i papi cosa hanno fatto? La guerra, fondamentalmente, le leggi, il conflitto, la politica. E dunque per tanto tempo la storia è stata questo. Non è una cosa completamente insensata, perché per esempio le guerre sono quei momenti in cui tutti sono coinvolti. Quando Mussolini decide di attaccare la Francia nel giugno 1940, perché “con qualche migliaio di morti siederemo anche noi al tavolo dei vincitori”, prende una decisione che è destinata a spazzare le vite dei 40 milioni di italiani che c’erano in quel momento e a farne morire 500mila. Quindi c’è una logica nel dire che le azioni dei potenti, la grande politica, la guerra sono una cosa importantissima da studiare, perché sono i momenti che coinvolgono davvero la vita di tutti. Poi però, all’inizio del Novecento, una generazione di grandissimi storici – quelli della rivista “Annales”: Marc Bloch, Lucien Febvre e gli altri – hanno scoperto che si era un po’ esagerato nel restringere l’attenzione alle biografie dei grandi personaggi e alla storia politico militare. E che c’era un’infinità di cose di cui valeva la pena di incuriosirsi.
Ricordo l’impressione che mi ha fatto leggere il carteggio tra Bloch e Febvre – siamo nel 1935 circa, il che vuol dire che nel frattempo è venuto su Hitler e si mette male – quando parlano del loro mestiere e si dicono: “Chissà se tra un anno saremo ancora qui o se saremo in un campo di concentramento o chissà dove”. In una di queste lettere Bloch dice: “Ho delle cose per la testa che mi stanno appassionando moltissimo. Avete mai riflettuto sul problema della marmellata?”. Il problema della marmellata, certo, perché in Francia tutti dicono la marmellata della nonna, un’antica tradizione in tutte le famiglie. Ma da quando si fa la marmellata? Risposta: da quando c’è la barbabietola da zucchero e lo zucchero costa poco, perché prima costava troppo. Quindi c’è la marmellata della nonna ma non della bisnonna, è qualcosa di nuovo che a un certo punto si è affermato. La marmellata ovviamente è un esempio, ma è per dire che non c’è niente che non ti incuriosisca. La storia dei sentimenti, ad esempio. …