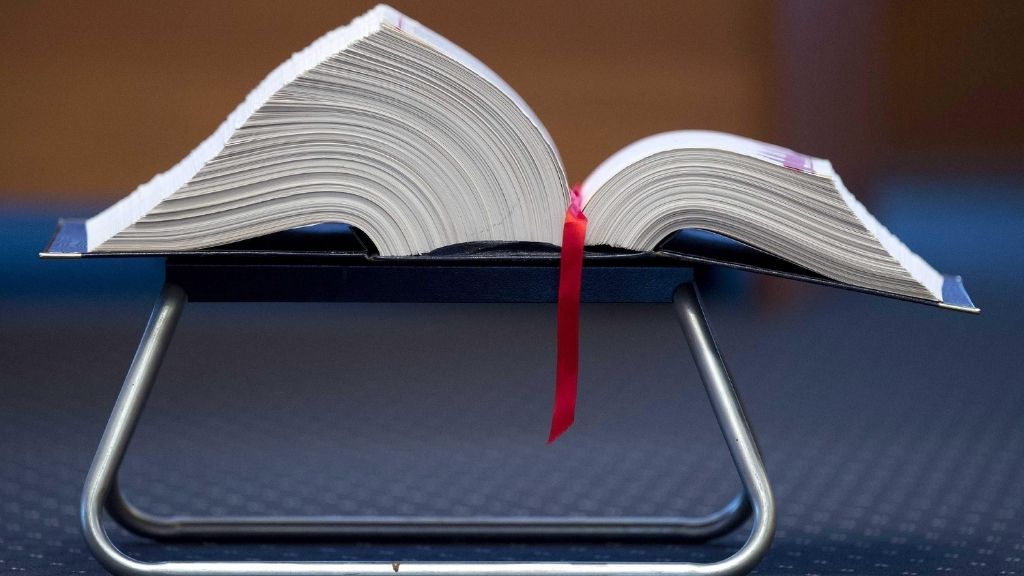Lascio agli storici ricostruire le vicende internazionali e italiane che condussero alla ratifica del Trattato di Maastricht (1992). Vediamone qui qualche aspetto economico per giudicare se tale trattato abbia avuto o meno qualche senso.
Prima di Maastricht
Di un’unione monetaria europea si era discusso già dagli anni cinquanta. L’analisi economica ne aveva però scoraggiata la creazione per il diverso grado di sviluppo e istituzioni dei Paesi europei. In particolare, la cosiddetta teoria delle aree valutarie ottimali aveva predetto una tendenza deflazionistica di tale unione. Infatti essa avrebbe con tutta probabilità condotto a squilibri commerciali fra i Paesi membri a vantaggio dei più competitivi. Robert Mundell, che di quella letteratura fu il fondatore, aveva in testa la Germania che già dal 1950 perseguiva con gusto surplus commerciali. Questa avrebbe certamente rifiutato di ridurre tali surplus espandendo la propria economia e accettando un’inflazione più alta al fine di importare di più dai partner. Il modello tedesco prevede infatti un’inflazione al di sotto di quella dei concorrenti e che siano questi ultimi a espandersi importando in tal modo di più e accrescendo la loro inflazione, ampliando così il loro gap competitivo con la Germania. Mundell predisse poi che non potendo gli altri Paesi conseguire disavanzi commerciali e indebitamento ad libitum, essi sarebbero stati alla fine costretti a deflazionare la propria economia a discapito di crescita e occupazione. Questo avrebbe avuto riflessi negativi sulla medesima Germania. Per carità, nei primi dieci anni dell’euro le cose sembrarono andare meglio, se non in Italia almeno in alcuni Paesi periferici come la Spagna. Ma era un’illusione dovuta a boom edilizi finanziati da prestiti esteri, foriera di una crisi finanziaria. Spiego subito perché.
All’epoca di Maastricht nessuno aveva previsto che, come sistematicamente accaduto nel passato in regimi di cambio fisso, anche l’euro avrebbe potuto generare un ciclo di indebitamento estero e boom edilizi nei Paesi periferici sfociando in una crisi finanziaria internazionale. La libertà di movimento dei capitali finanziari e la scomparsa del rischio di cambio fra i Paesi membri di un’unione monetaria costituiscono infatti l’humus ideale per i prestiti internazionali. Era stato così col Gold Standard, e con le politiche di parità fisse col dollaro di molte regioni emergenti culminate in numerose crisi negli anni novanta. La convergenza dei tassi di interesse a lungo termine verso i più bassi livelli tedeschi fece il resto. Questa fu dovuta alla convinzione dei mercati che, in barba alla no bail out clause del Trattato di Maastricht, nessun Paese europeo sarebbe stato lasciato fallire, per cui tutti i titoli di Stato e bancari dell’unione monetaria erano da considerarsi ugualmente sicuri…