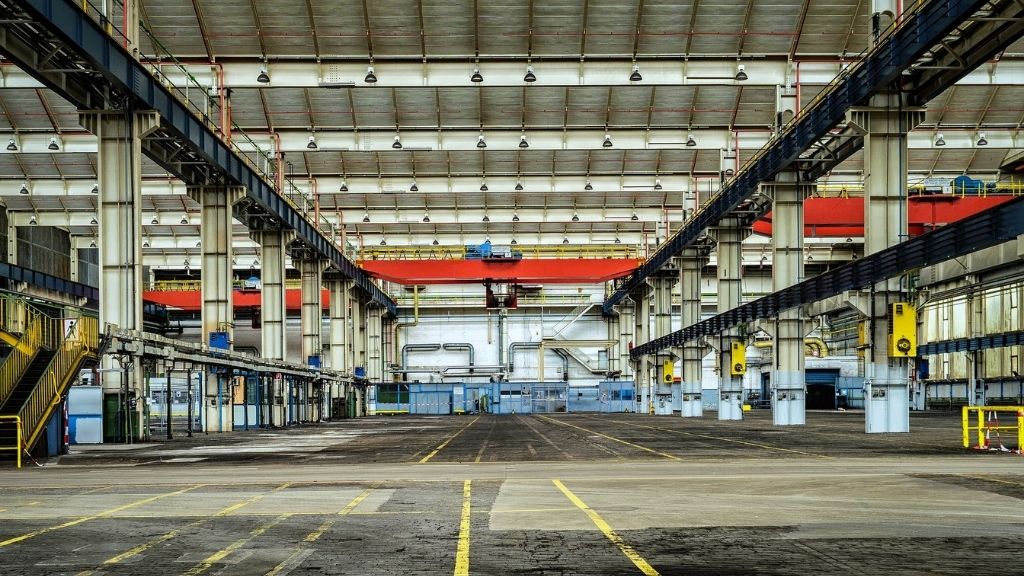Prima di finire questo articolo ero stressato. Era la fine delle vacanze invernali, ma ho comunque deciso di accettare un lavoro da freelance. Avrei potuto scegliere di sdraiarmi su una spiaggia vicino al fiordo di Oslo, andare al cinema o semplicemente sedermi accanto alle piante di pomodoro sul mio balcone. Invece, ho accettato un incarico che ha richiesto molte ore di lavoro. Lo stress che ho sentito mentre si avvicinava la scadenza ha creato una sensazione familiare nel mio stomaco. Ho dormito meno, sono diventato più impaziente e meno presente con gli altri. Fuori splendeva il sole, sul mio conto in banca c’erano abbastanza soldi, ma comunque ero lì, a lavorare alla luce di un computer.
Come la maggior parte delle persone, provo una certa curiosità verso questa attività che chiamiamo “lavoro”. Quando non dormo, non faccio la doccia, non cucino o mangio, passo la maggior parte del mio tempo a lavorare. Mi piace avere ore libere, ma non troppe. In carcere, i prigionieri che vengono messi in isolamento chiedono di uscire per lavorare. Preferiscono fare il bucato e pulire i pavimenti con rapinatori e assassini piuttosto che girarsi i pollici.
La maggior parte dei vincitori della lotteria non smette di lavorare quando diventa ricca. Secondo uno studio pubblicato sulla Harvard Business Review, più soldi fanno le persone, più lavorano. Negli Stati Uniti, il 62% delle persone con i redditi più alti lavora più di 50 ore a settimana. Oltre un terzo di loro lavora più di 60 ore e uno su dieci lavora 80 ore a settimana. Nel frattempo, i loro lussuosi giardini e le loro piscine sono vuoti e le loro auto di lusso raccolgono polvere nei garage.
Pigrizia evolutiva
È nella nostra natura voler lavorare il più possibile? Forse l’evoluzione ci ha fatto apprezzare automaticamente coloro che lavorano sodo e disprezzare coloro che se la prendono comoda. Forse siamo predisposti a essere diligenti.