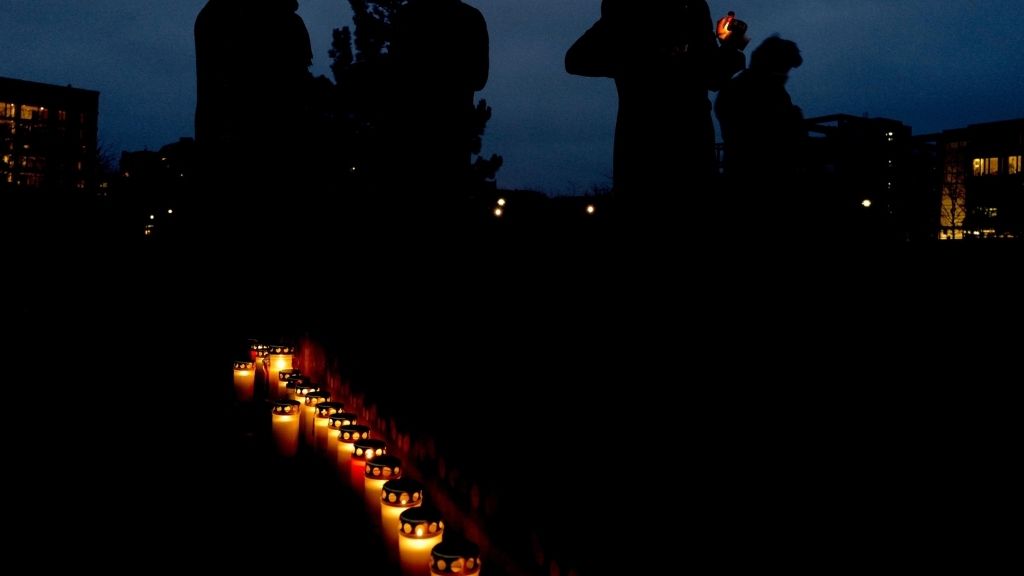Nel settembre 2020 Geoffrey Nice, già procuratore al processo del serbo Slobodan Milošević per crimini di guerra, ha annunciato la creazione del Tribunale Uyghur per «investigare sui presunti crimini contro l’umanità e genocidio contro uiguri, kazachi e altre popolazioni musulmane turkmene». Il 23 marzo dell’anno scorso 17 deputati hanno depositato al parlamento del Regno unito una mozione per condannare le «atrocità contro gli uiguri nello Xinjiang». Il 6 maggio la Commissione affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa ha tenuto un’udienza sulle «atrocità contro uiguri e altre minoranze nello Xinjiang». Tra ottobre e dicembre le “atrocità”, il “genocidio”, i “crimini contro l’umanità” cinesi in Xinjiang hanno riempito le pagine della stampa internazionale, dal Guardian ai giornali turchi, ad Haaretz. Il 20 gennaio di quest’anno il parlamento francese ha denunciato a maggioranza «la violenza perpetrata dalla Repubblica popolare cinese contro gli uiguri perché costituisce un crimine contro l’umanità e un genocidio».
In queste denunce vengono usate in modo intercambiabile le parole “atrocità”, “massacri”, “genocidio”, “torture”, “crimini contro l’umanità”. In altri casi si parla di “crimini di guerra”. Questi termini sono diventati talmente frequenti nel discorso politico da non destare più alcuna reazione. Inflazionati, hanno perso la capacità di scandalizzarci, indignarci, perfino di farci riflettere.
Mai ci fermiamo a considerare che nella storia dell’umanità, fino alla fine dell’Ottocento, queste categorie erano totalmente estranee al discorso politico. Raro oggetto d’indignazione morale (vedi Bartolomé de las Casas sui massacri degli indios) non erano mai divenute argomento per intraprendere azioni politiche o militari. Come d’altronde nessuno era mai stato condannato per “crimini di guerra”. Il nemico sconfitto poteva essere ridotto in schiavitù, o venire deportato, ma non per questo era considerato un criminale o un malfattore: pena sufficiente era la sconfitta – con le sue implicazioni.
La differenza sostanziale tra i “crimini di guerra” e le “atrocità” sta nel fatto che i primi vengono processati e condannati a guerra finita, come sanzione degli sconfitti e legittimazione dei vincitori, mentre le “atrocità” sono usate come argomento per intraprendere la guerra, sono uno dei modi in cui la modernità “costruisce” il nemico: la stessa azione è definita “atrocità” prima …