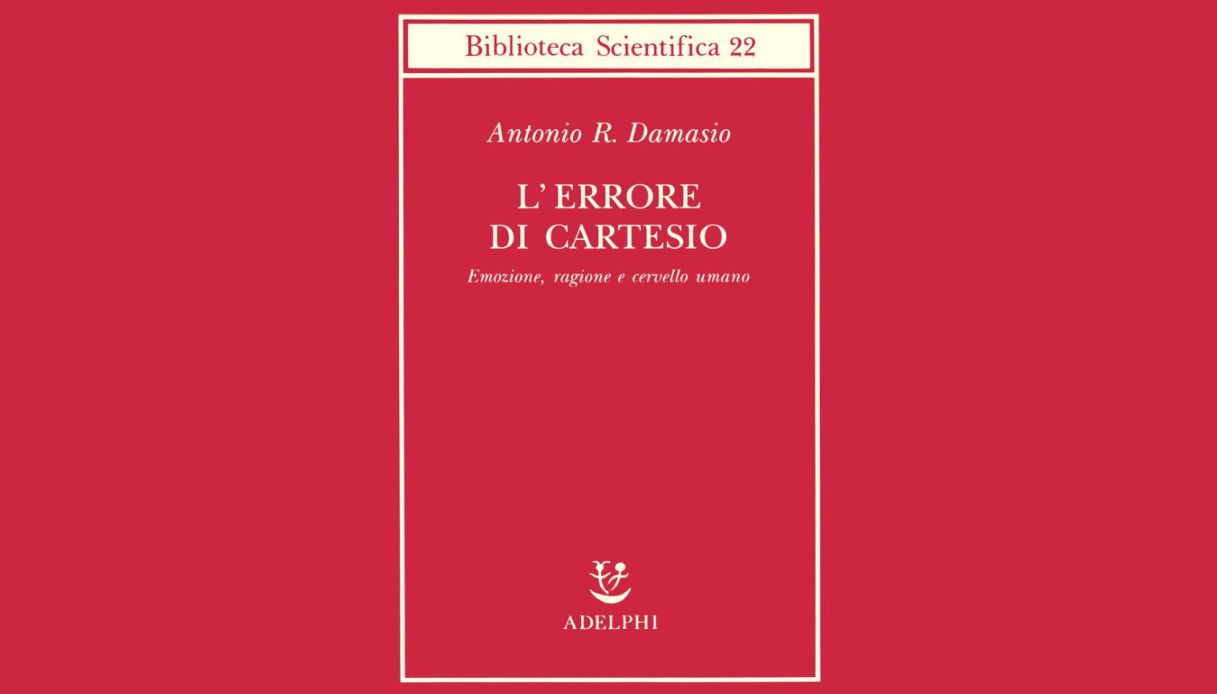Se vi trovaste a discutere con un giudice sulla natura delle sue decisioni, molto probabilmente il vostro interlocutore togato decanterebbe la razionalità delle sentenze, massima espressione della logica giuridica. È a dire il vero un’impostazione comune, retaggio forse di quelle concezioni illuministico-cartesiane che vogliono la ragione totalmente separata dalle emozioni, puro pensiero contrapposto alla corporeità emotiva.
Si tratta di un clamoroso abbaglio; ed è un grande neuroscienziato portoghese, Antonio Damasio, a guidarci sulla retta via nel suo classico saggio L’errore di Cartesio, un lungo viaggio nei meandri della mente umana. Quello di Damasio è uno di quei libri-miniera, che richiedono un’opera di faticoso scavo da parte del lettore ma che riservano, alla fine di un’ostica discesa nelle profondità del sapere, la vista di gemme di rara bellezza. Ci troviamo infatti di fronte a un mondo di nozioni e di immagini “controintuitive”, del tutto ribaltate rispetto alla piatta dimensione dei luoghi comuni.
Il libro si apre, quasi fosse un romanzo, con la curiosa storia di Phineas Gage[1], caposquadra venticinquenne di un’impresa di costruzioni, trapassato alla testa da una barra metallica: si salverà, mantenendo miracolosamente intatte le capacità cognitive, ma perdendo irrimediabilmente quella che Goleman ha poi definito, in un noto saggio[2], l’intelligenza “emotiva”, ovverosia la capacità di conoscere e controllare le proprie emozioni (autocontrollo) e di relazionarsi con gli altri (empatia). Questa inedita dissociazione rivelerà un aspetto sorprendente: se nelle operazioni logico-matematiche il giovane ragazzo aveva mantenuto intatte le sue facoltà, al contrario la sua attitudine di prendere decisioni razionali era andata totalmente perduta. In qualunque decisione, Gage manifestava un’assoluta incapacità, tanto da perdere completamente la possibilità di pianificare il proprio futuro come qualsiasi persona normale.
Che cosa vuol di…