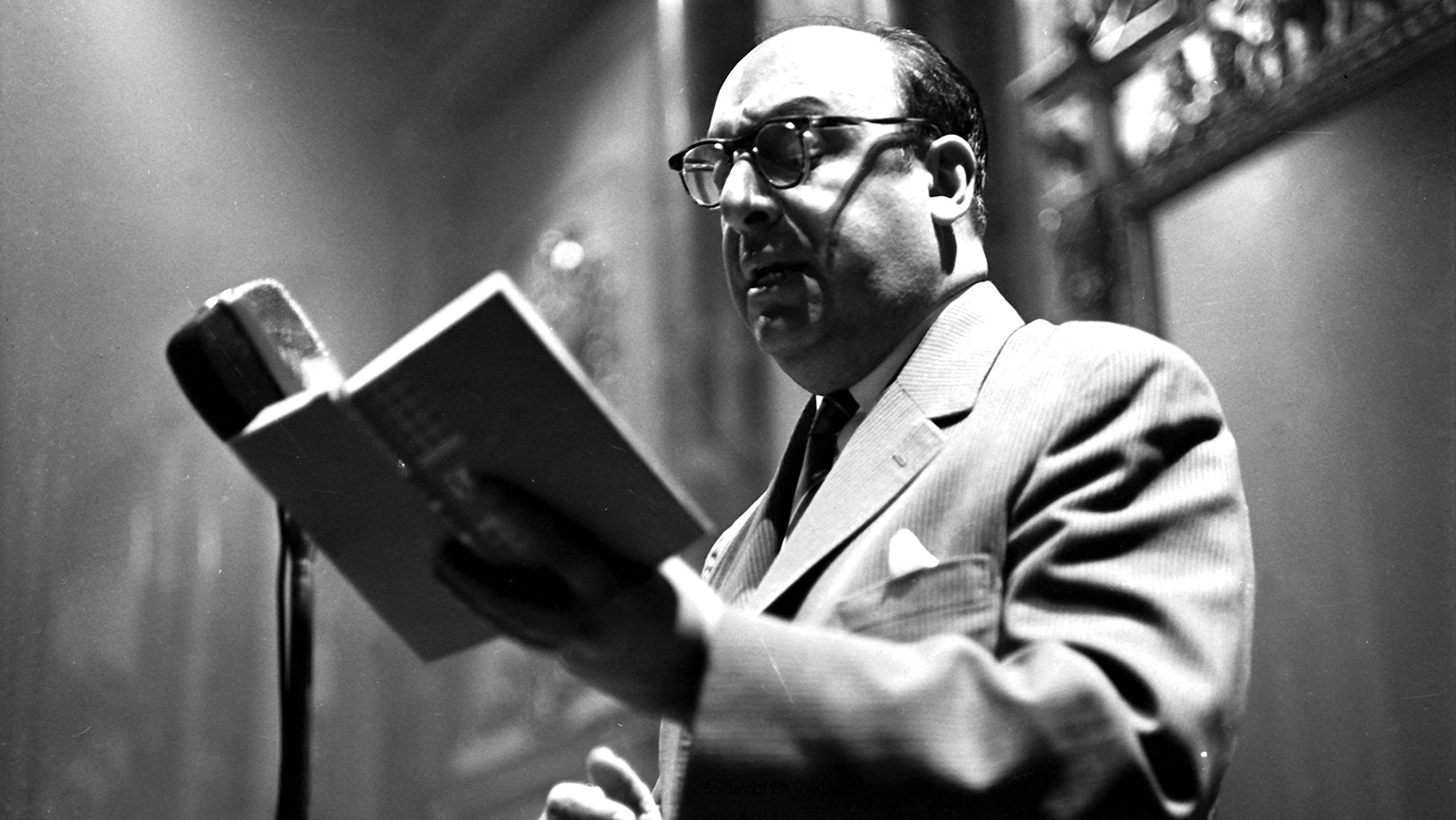Pablo Neruda muore il giorno dell’equinozio della primavera australe, il 23 settembre del 1973.
L’11 settembre aveva ricevuto la telefonata di Allende all’alba che gli comunicava la rinuncia ad andare a Isla Negra a incontrarlo: «C’è rumore di sciabole», disse il presidente. Qualche ora dopo Neruda ascoltava le ultime parole di Allende a radio Magallanes. “È la fine”, disse.
“Non è vero, sarà un altro tentativo di golpe, il popolo non lo permetterà”, rispose Matilde Urrutia la sua terza moglie.
Aveva ragione lui che, nei giorni del golpe, osservando con sconcerto la gente in strada a festeggiare i militari, saputo dell’omicidio e delle torture su Victor Jara («è stato come uccidere un usignolo, dicono che lui cantava, cantava, e questo li incarogniva»), considerando i militari «peggiori dei nazisti perché assassinano i propri compatrioti», Neruda si chiede: «Ma dove stavano i cileni capaci di fare tutto questo? E perché noi non li vedevamo?».
Neruda aveva avuto una vita straordinaria, scandita però dalle tremende incursioni fasciste nella storia del mondo e nella sua personale. Era console cileno in Spagna, negli anni ’30, quando i militari rovesciarono la repubblica con un golpe e, tra gli altri, fecero uccidere due grandi amici di Neruda: i poeti Federico Garcia Lorca e Miguel Hernandez.
Fu lì che apparve per la prima volta un uccello sinistro, il Condor, in questo caso con l’apertura alare della legione aerea nazista in supporto di Franco.
Negli anni ’50 Neruda impatta con un altro regime militare, quello del generale cileno Gabriel González Videla, eletto anche coi voti delle sinistre e poi passato al servizio della destra reazionaria e dei militari. Videla riaprì il carcere di Pisagua per incarcerare i dissidenti.
Il porto di Pisagua, situato nella regione desertica di Tarapacá nell’estremo nord del paese, fu tra i maggiori porti del pacifico meridionale durante la “corsa al salnitro”. Appartenente originariamente al Perù, il 2 novembre 1879 il porto fu invaso dalle truppe cilene nel cosiddetto “Desembarco de Pisagua”. Scoppiò la sanguinosa guerra tra il Perù e il Cile che si concluse con il definitivo passaggio del porto e della città in mani cilene. Data la sua ubicazione in una regione desolata e desertica, Pisagua fu ben presto adibita a centro di detenzione e vi fu impiantato poi quello che è stato il più famigerato campo di concentramento del Cile e uno dei peggiori dell’intera America Latina. L’iniziatore fu il…