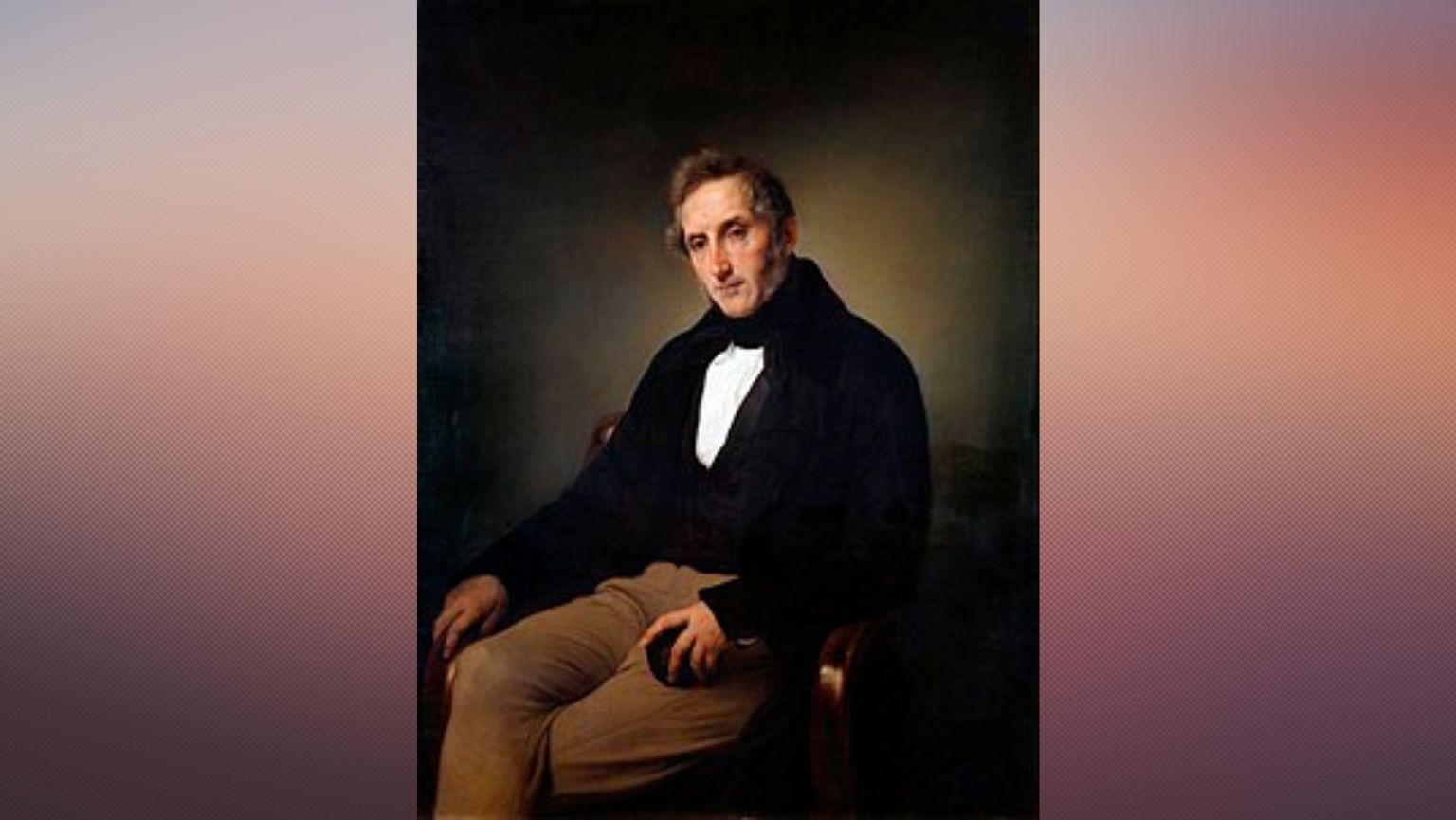Premessa contemporanea ad Alessandro Manzoni
Il 4 febbraio del 2022, un articolo uscito sul blog Daily Kos ha raccontato di una coppia di Temecula, California, colta da un video poi postato su Tik Tok in circostanze che i due avrebbero poi avuto occasione di rimpiangere. Sandra e Roger Miller hanno scontato quel video con un licenziamento (Sandra) e una sospensione dal lavoro (Roger). Nel video, filmato nel parcheggio di un centro commerciale di Newport Beach, a sud di Los Angeles, si vedono due donne dai tratti asiatici che all’improvviso vengono insultate dalla signora Miller con pesanti epiteti razzisti e l’ingiunzione di “smettere di diffondere il Covid”. Roger Miller aggiunge qualche commento sul comunismo, Sandra tocca la ringhiera di una rampa di scale e dice: “Morirò per tutti questi germi”. Mentre salgono sulla loro automobile mostrando il dito medio alle donne, si sente Sandra Miller gridare: “Tornatevene in Cina!” Al che una delle donne osserva tranquillamente: “Veramente, non siamo nemmeno cinesi”.
È stata una fortuna che l’incontro non sia degradato in violenza fisica, perché durante gli anni del Covid-19 le aggressioni nei confronti degli asiatici americani sono aumentate esponenzialmente, soprattutto dopo che il presidente Trump aveva cominciato a ripetere l’espressione “virus cinese”. Nel 1918, allo scoppio dell’ influenza spagnola, non c’erano state sollevazioni popolari contro gli spagnoli (l’influenza era nata in Francia, ma per via della censura i giornali degli Stati in guerra non ne potevano parlare, mentre nella Spagna neutrale le notizie uscivano), ma le teorie di cospirazione non erano mancate. S’era anche detto che le “potenze” intendevano diminuire il numero degli abitanti del pianeta, e poiché la guerra non era stata sufficiente avevano scatenato l’epidemia.
Ma ciò che è interessante nell’episodio californiano è la supposizione che la malattia si potesse trasmettere attraverso germi rimasti sulla ringhiera di una scala dopo che alcune mani asiatiche l’avevano toccata o, per meglio dire, “unta”. Il fatterello dimostra, se ce ne fosse bisogno, che le teorie di cospirazione non muoiono mai. Possono trasmettersi dall’antica credenza romana che la peste fosse causata da veleni diffusi ad arte, attestata da Tito Livio, fino alla peste di Milano del 1630 e al Covid-19 nel 2022. Mani asiatiche toccano una ringhiera che infetterà corpi americani. Mani asiatiche chissà come immuni dalla stessa malattia che stanno spargendo, così come gli untori del 1630 dovevano essere miracolosamente immuni dalla sostanza contagiosa contenuta in quell’unguento che loro stessi, con le loro stesse mani, spalmavano sui muri.
Durante i primi mesi della pandemia, i commentatori non hanno risparmiato ampie scorribande sulle grandi descrizioni del passato, da Tucidide a Lucrezio, da Boc…