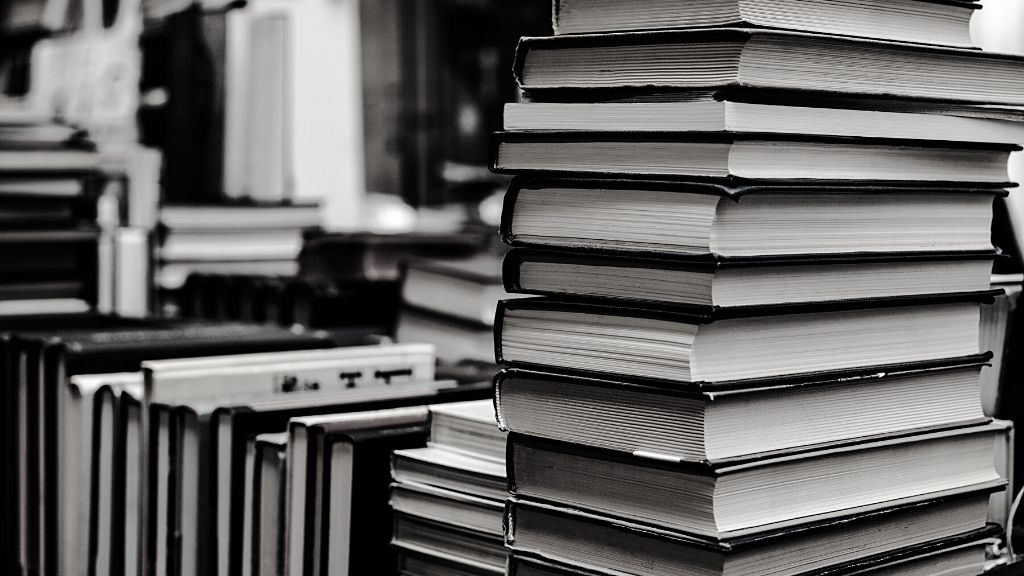Qualche mese fa, Meghan Cox Gurdon, critica letteraria di libri per bambini del Wall Street Journal, denunciava in un articolo i rischi del movimento statunitense #DisruptTexts che, «usando una buona idea, vale a dire che i bambini dovrebbero avere accesso a libri con protagonisti di razze ed etnie diverse, ne promuove una perniciosa e cioè che ai bambini nuoccia il confronto con una letteratura classica che non si conforma alla sensibilità contemporanea su razza, genere e sessualità», e lanciava un grido d’allarme per il fatto che alcuni insegnanti negli Usa si oppongono all’insegnamento di Shakespeare nel timore che gli studenti possano essere feriti dalla violenza, dalla misoginia e dal razzismo delle sue commedie.
A partire da quell’articolo la rivista Salmagundi, del Skidmore College, ha aperto un simposio sul tema cui hanno contribuito, con interventi di segno diverso che rendono la complessità della questione, il professore di Inglese alla University of Virginia Mark Edmundson; la scrittrice Siri Hustvedt; il direttore di Salmagundi e docente di Inglese presso il Skidmore College Robert Boyers; e Rochelle Gurstein, autrice di The Repeal of Reticence. A History of America’s Cultural and Legal Struggles over Free Speech, Obscenity, Sexual Liberation, and Modern Art.
Dopo quello di Mark Edmundson, pubblichiamo questa settimana l’intervento di Siri Hustvedt.
***
L’articolo “Shakespeare Wasn’t Woke” di Meghan Cox Gurdon è un testo che va letto tanto per quello che dice quanto per quello che non dice. I nemici contro cui Gurdon punta il dito sono le attiviste di #Disrupt Texts che «sfidano il canone tradizionale al fine di creare un curriculum di arti linguistiche più inclusivo, rappresentativo ed equo». La sua paura è che i bambini vengano «separati» dai «classici», che hanno «guadagnato il loro posto nel pantheon letterario» come testi amati e influenti, e siano quindi privati della «loro eredità».
Scrivendo su quella che chiamò «critica laica», Edward Said notò «l’assunto ideologico quasi inconsapevolmente sostenuto che il modello eurocentrico per le discipline umanistiche rappresenti un argomento naturale e appropriato per lo studioso umanista. La sua autorevolezza deriva non solo dai monumenti letterari ortodossi tramandati di generazione in generazione, ma dal modo in cui questa continuità riproduce la continuità filiale della procreazione biologica». Said non aggiunge che la versione letteraria della procreazione è avvenuta per lo più senza madri, generata dalla sola paternità. Questa è la fantasia di Harold Bloom in L’angoscia dell’influenza (1973). Attraverso il conflitto edipico con altri grandi scrittori maschi, i grandi scrittori maschi, come Zeus, danno vita ai libri dalle loro teste. Il libro di Bloom Il canone occidentale è apparso nel 1994. La misura della grandezza? «Shakespeare è il canone», scrive Bloom. «Egli stabilisce gli standard e i limiti della letteratura».…