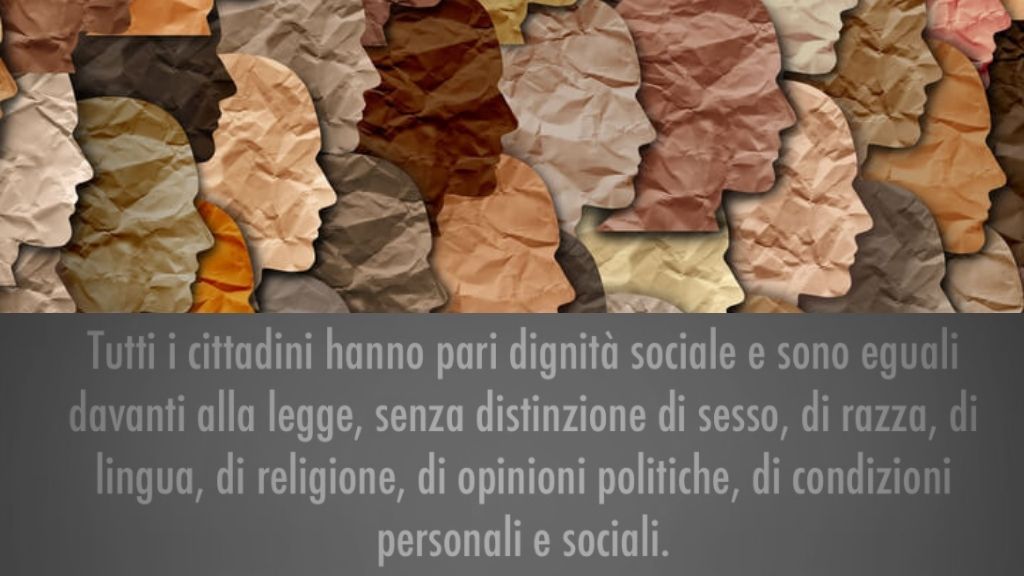Avete presente quei fiumi che scorrono sotterranei per poi riemergere fragorosamente in superficie? È un’immagine che descrive efficacemente l’andamento del dibattito sulla razza nel nostro Paese: il tema sembra rimanere un po’ in sottofondo fino a quando un fatto di cronaca o anche un’iniziativa giornalistica lo portano con prepotenza alla ribalta. Per poi inabissarsi nuovamente quando l’eco della notizia si spegne, in attesa che un altro sussulto lo riporti sotto i riflettori. Ma, mentre l’interesse dell’opinione pubblica va a fasi alterne, la distanza tra coloro che sono contrari all’uso della parola razza e quelli che ne prendono le difese rimane intatta; esiste la possibilità di trovare un punto d’incontro tra i due punti di vista in nome di principi e valori condivisi? Personalmente penso di sì.
Cominciamo dall’ultima riemersione. Non molto tempo fa, il 30 luglio, in un editoriale seguito da commenti di personalità del mondo della cultura, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari ha lanciato la proposta di “espellere” la razza, una “parola malata” e “che racchiude il seme dell’odio”, dai testi ufficiali Ue e dalle nostre leggi, in primis dalla Costituzione della Repubblica. Come ha fatto la Francia nel 2018 e come è stato proposto recentemente da un ampio schieramento politico in Germania.
Si tratta di un obiettivo che poggia su motivazioni in grado di resistere a una discussione critica? E poi intervenire sulla presenza della parola può essere realmente utile? Per dare delle risposte che siano adeguate alla complessità della questione è opportuno ripartire dal dibattito sulla presenza della parola razza nella Costituzione italiana che ha coinvolto antropologi, genetisti, filosofi e altri studiosi a partire dal 2014 (Biondi e Rickards, Scienza in rete, 2014; Destro Bisol et al. 2017). Un confronto interdisciplinare che ha avuto come animatore e guida Pietro Greco, umanissimo maestro di giornalismo e di impegno civile scomparso alla fine del 2020.
Complessità è spesso un termine abusato, ma non questa volta. Parlando di razze umane, abbiamo a che fare non solo con la diversità biologica e culturale, ma anche con il grande tema dei rapporti tra natura e cultura. Parlando di leggi, dobbiamo tenere conto non solo dell’ordinamento giudiziario, ma interrogarci anche su questioni etiche e morali. E inf…