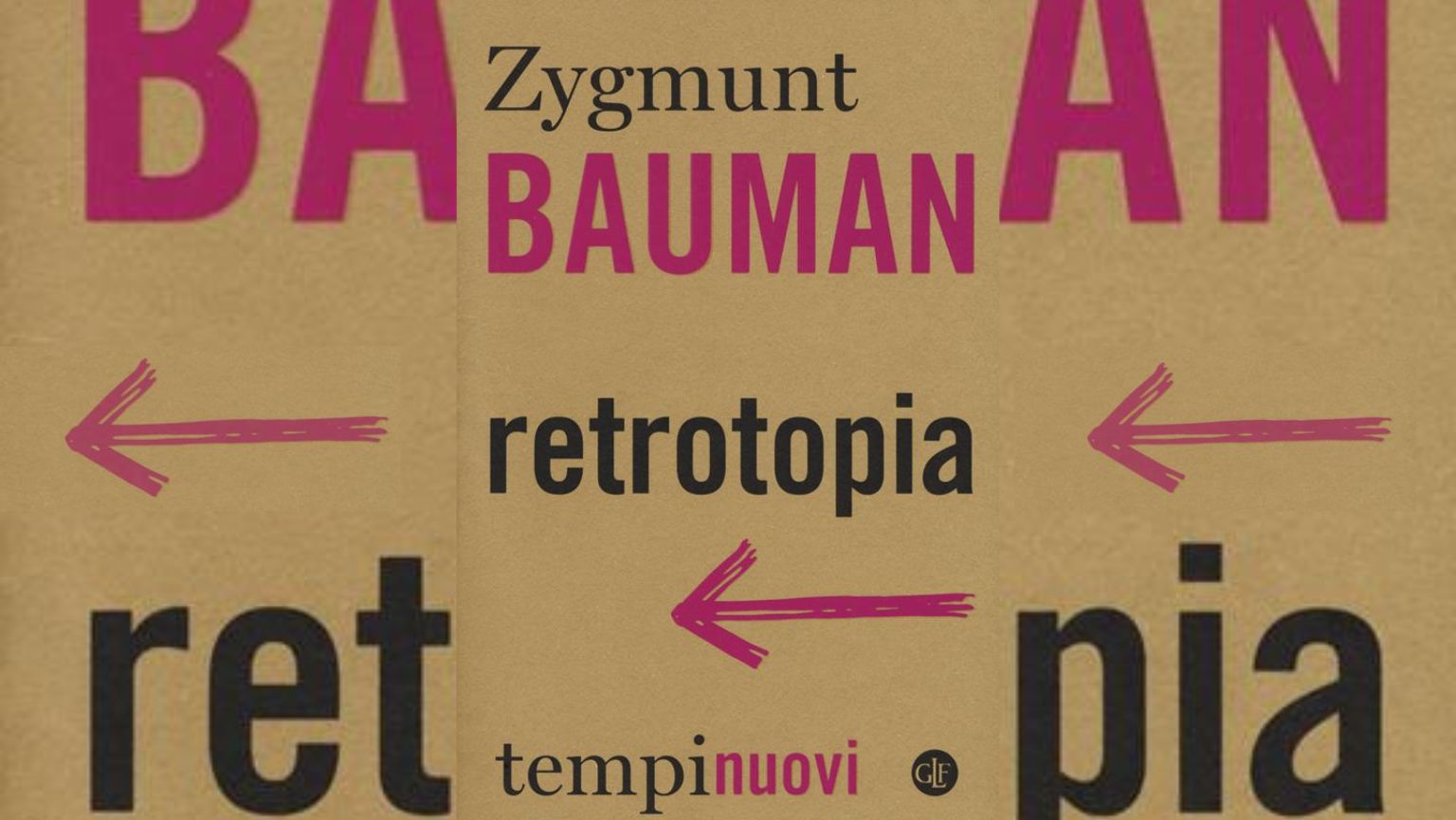Qual è la dimensione temporale dell’utopia? Credo non sia azzardato rispondere che è il futuro, in cui si proiettano le speranze e le progettualità. Eppure Zygmunt Bauman, teorico della modernità liquida, nel suo ultimo saggio, Retrotopia, pubblicato da Laterza nel 2017, lancia lo sguardo dell’analisi all’indietro, riprendendo la lettura che Walter Benjamin fa del noto quadro di Paul Klee, l’Angelus Novus. Ribattezzato l’angelo della storia, ha il volto rivolto al passato, alle macerie che esso ha prodotto e alle vittime con cui vorrebbe restare, mentre, tuttavia, una tempesta lo spinge irresistibilmente verso il futuro.
Nel nostro tempo, caratterizzato da incertezze e precarietà, il passato, scrive Bauman, «viene spostato tra i crediti e rivalutato, a torto o a ragione, come spazio in cui la scelta è libera e le speranze non son ancora screditate»[1]: il XX secolo, è iniziato, sostiene Svetlana Boym, con un’utopia futurista per chiudersi con la nostalgia. Alla smania del progresso, si è sostituita «l’epidemia globale di nostalgia». Le speranze di miglioramento, infatti, sono state reinvestite nel ricordo di un passato apprezzato per la sua stabilità e affidabilità mentre il futuro è diventato la sede dei nostri incubi. Affiorano, perciò, ovunque retrotopie, «visioni situate nel passato perduto/rubato/abbandonato ma non ancora morto, e non […] legate al futuro, non ancora nato, quindi inesistente»[2].
L’orizzonte dell’utopia non si riesce a distinguere e la terra dell’abbondanza è avvolta dalla nebbia né si intravede un mondo migliore. Soprattutto i genitori prevedono che i figli staranno peggio di loro: l’avvenire appare minaccioso, mentre il ritorno al passato un itinerario di purificazione dai danni che il futuro ha provocato quando si è fatto presente. Anche il divario tra cittadino e politica, di fronte alla delusione per l’incapacità di costruire una società più solidale e giusta e accogliente per tutti, si è ulteriormente scavato: dinanzi a tale situazione, come scrive Ulrich Beck, ogni essere umano cerca soluzioni personali ai problemi che ha di fronte. L’obiettivo non è più una società migliore ma l’avanzamento della propria posizione individuale nell’ambito di un contesto che si percepisce come impossibile da correggere.
***
Hobbes, scrive Bauman, ha fallito: il Leviatano non è riuscito a domare la bestia né a mitigare l’istinto alla violenza degli esseri umani. La loro aggressività endemica non è diminuita: come ha scritto Norbert Elias, il processo di civilizzazione si è risolto in una riforma delle buone maniere che si è limitata a celare alla vista e a camuffare gli atti di violenza o a esternalizzarli e sussidiarizzarli a esseri umani considerati inferiori. Li ha affidati a “intoccabili”, capri espiatori su cui scaricare i peccati della collettività, finendo per aumentare il vuoto sociale e l’«inattenzione civile», «l’arte di distogliere lo sguardo dagli estranei, sul marciapiedi, sui mezzi di trasporto pubblici o in sala d’attesa dal dentista»[3]. Non è riuscito, però, a correggerli: l’animale resta in agguato. Dobbiamo, perciò, abbandonare l’illusione di un mondo senza violenza e che ci sia un Leviatano capace di proteggerci e farsi custode della nostra s…