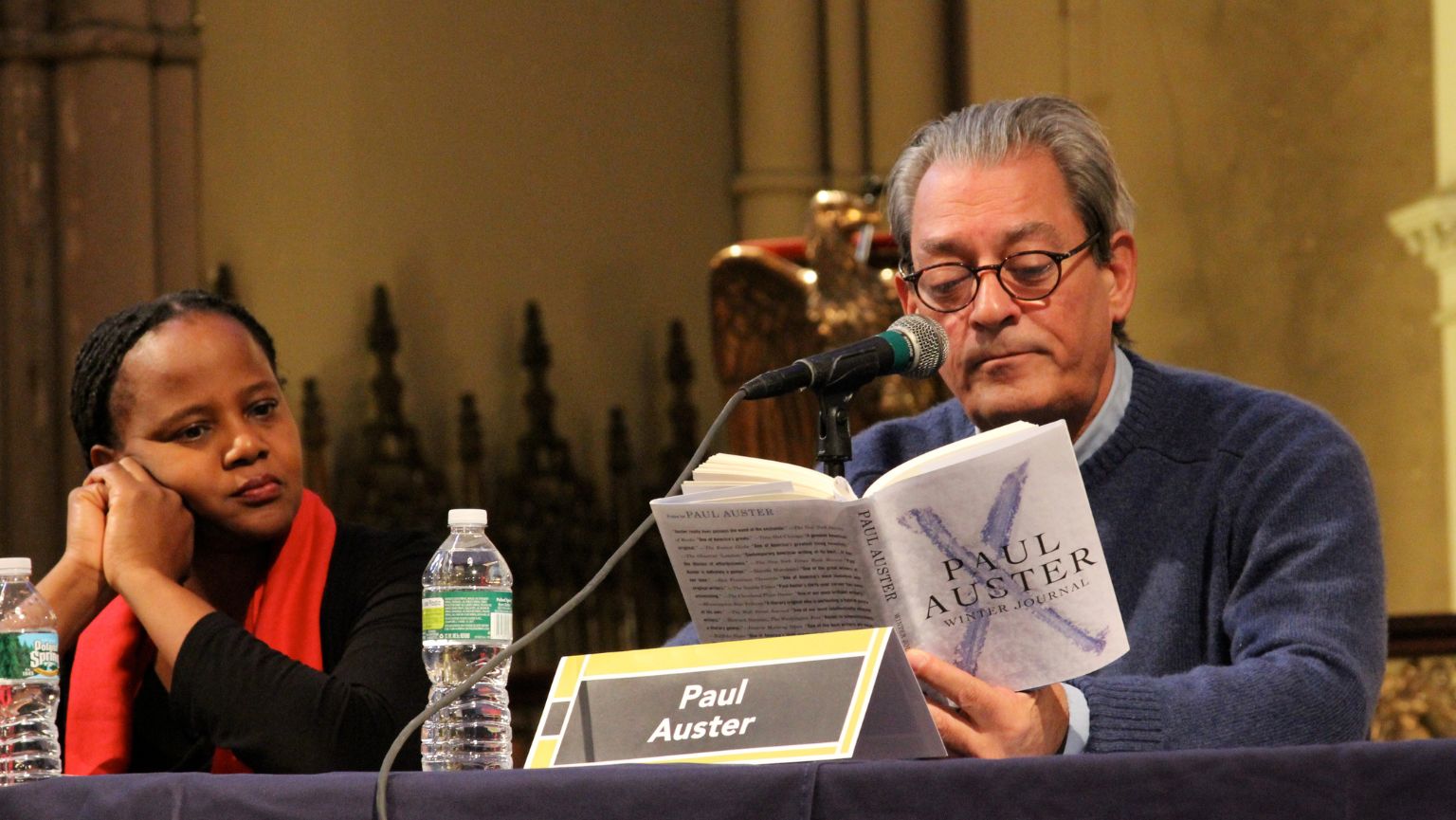KABUL – “La peggiore catastrofe umanitaria al mondo”, “Milioni di bambini malnutriti”, “Nessun diritto per le donne e le minoranze”.
È trascorso un anno dalla presa dell’Afghanistan da parte dei talebani, e quello che si vede camminando per le strade di Kabul e del resto del paese, non ci racconta nulla di buono. Lo stesso vale per le cifre, statistiche che mettono in guardia ma che spesso non spiegano la disperazione di una madre che deve dire ai figli che la sera non si cena perché non c’è nulla, o di un uomo che non lavora da mesi perché oggi chi non è allineato con il nuovo governo talebano non lavora ed è stato sostituito da qualcun altro con probabilmente meno competenze, così come è avvenuto per tutti i ruoli che ricoprivano le donne, presi da qualcun altro.
E lo stesso vale per tutte le organizzazioni umanitarie e delle Nazioni Unite che dicono incessantemente che questo paese va aiutato, che non ce la fa da solo. L’Afghanistan è un sistema completamente crollato, un esperimento occidentale andato male, dove gli americani pensavano che per portare la democrazia bastasse ordinarlo e metterci tanti soldi senza conoscere per nulla il posto dove si trovavano, basato su etnie, tradizioni, religioni, separato da usanze e montagne, dove neanche la gente si assomiglia perché gli spazi sono talmente grandi che si passa dagli occhi allungati degli hazara sciiti ai bruni pashtun con gli occhi verdi. Un paese che parla lingue diverse, che non si conforma, che ancora crede nelle antiche usanze, mentre lotta per sentirsi moderno sfoggiando telefonini di ultima generazione, ma dove si trovano solo auto usate.
Con l’arrivo dei talebani un anno fa, il paese si è in qualche modo uniformato nella sua tristezza. Per le strade più sicure perché i talebani non devono più attaccare gli americani e gli alleati della Nato, circola la paura come una malattia che contagia tutti. “Non possiamo fare niente se non andarcene”, è forse la frase più ricorrente in questi giorni di anniversario.
Per chi non è un talebano o non è vicino al movimento radicale, vivere in Afghanistan è diventata una sorta di punizione collettiva la cui unica speranza è quella di fuggire. Prima non era un paese perfetto, la corruzione era endemica, la guerra ha portato a quattro milioni di sfollati, il traffico di droga governava parte dell’establishment afgano, ma c’era la speranza che prima poi le cose cambiassero. Gli afgani sono andati a votare, senza spesso bene capire perché. Le donne si sono riversate nelle scuole e dalle solite professioni di maestra e dottoressa, hanno cominciato a penare che potessero essere altro, magari aprire un ristoran…