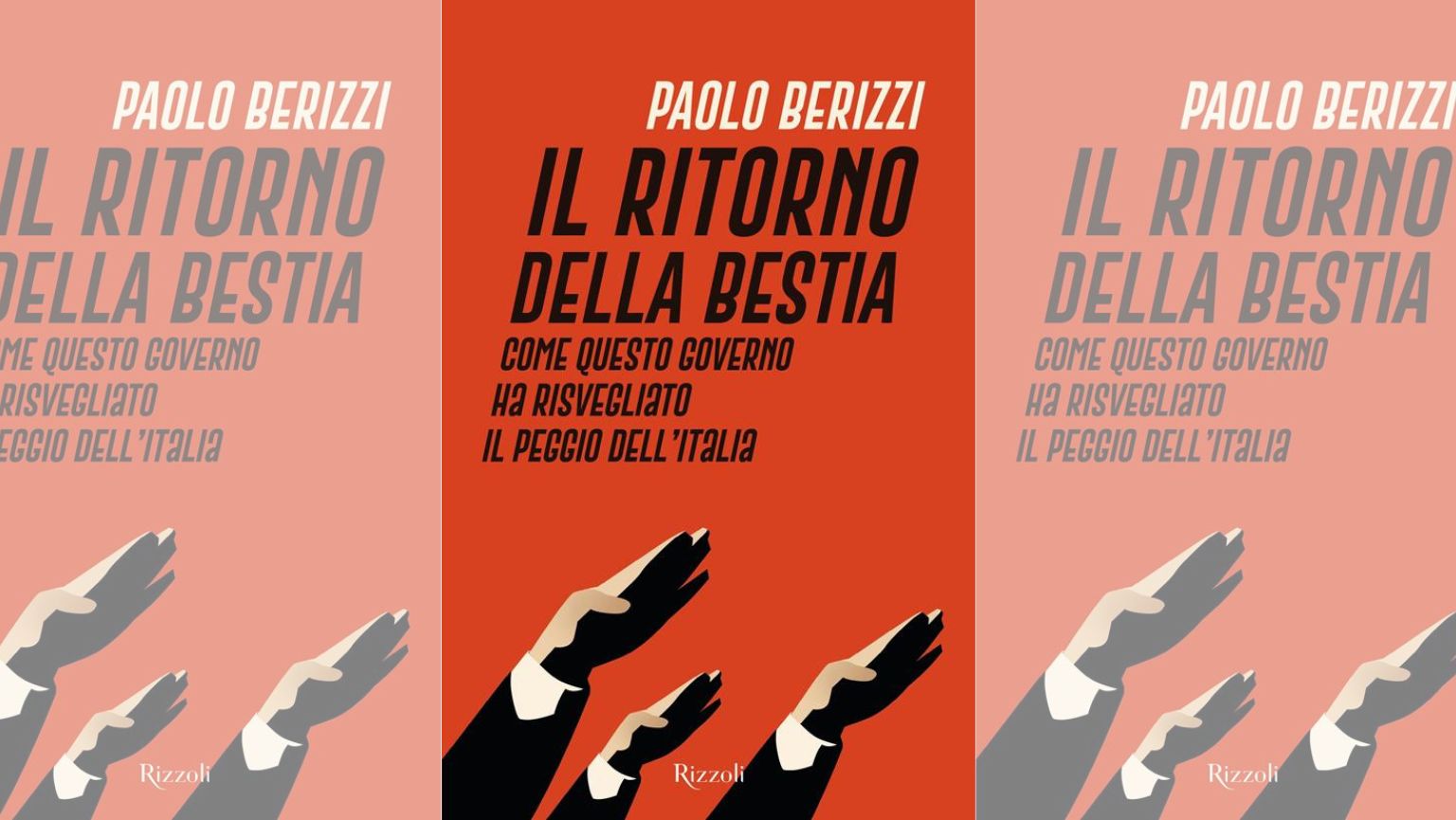Dal mese di marzo 2023 il nome di Cutro è tristemente collegato al fenomeno migratorio italiano. La prima volta a seguito della drammatica morte di oltre cento persone, naufragate nel tentativo di approdare sulle coste della Calabria; la seconda avviene pochi giorni dopo, con l’emanazione del Decreto-legge 20/2023, che il 5 maggio verrà convertito con Legge n. 50/2023. In un quadro che la filosofa Hannah Arendt definirebbe una banalità del male, sia il decreto sia la legge prenderanno il nome del luogo della strage, andando ad alimentare l’oblio degli eventi di morte.
Nonostante l’Italia sia terra d’asilo e immigrazione da oltre vent’anni, ancora una volta la dimensione dell’emergenza fa da protagonista e responsabile delle morti ai confini. Nel frattempo, assistiamo all’affermarsi di quelle che il filosofo Achille Mbembe[1] definirebbe necropolitiche e ideate da uno Stato miope che nasconde chi muore e definisce chi merita protezione.
La frammentazione del sistema italiano impedisce di garantire l’accesso ai diritti e alla possibilità di “fare casa”, andando oltre la mera accoglienza. La costante precarietà determina l’emergere di conseguenze ancor più gravi e profonde su chi è vulnerabile[2]. Ma come si arriva a tutto questo?
Gli ultimi vent’anni di accoglienze
In Italia, si inizia a parlare di accoglienza e di rifugiati a partire degli anni Novanta, in cui non esistevano esperienze o soggetti istituzionali dedicati, e fu la società civile a svolgere un ruolo cruciale nel gettare le basi dell’odierno sistema asilo italiano. Da questi sforzi viene istituzionalizzata nel 2002 la rete Sprar – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati[3] – che, tuttavia, negli anni si rivela insufficiente, specialmente nei momenti di maggiori approdi. Con la crisi dei rifugiati del 2015, sebbene residuale rispetto alle frontiere più esterne dell’Europa, in Italia, vengono istituiti i centri di accoglienza straordinaria (CAS)[4].
In questo periodo si consolida la distinzione tra il primo e secondo livello di accoglienza, il primo fatto dei centri governativi per richiedenti, quali i CAS, il secondo dalla rete S…