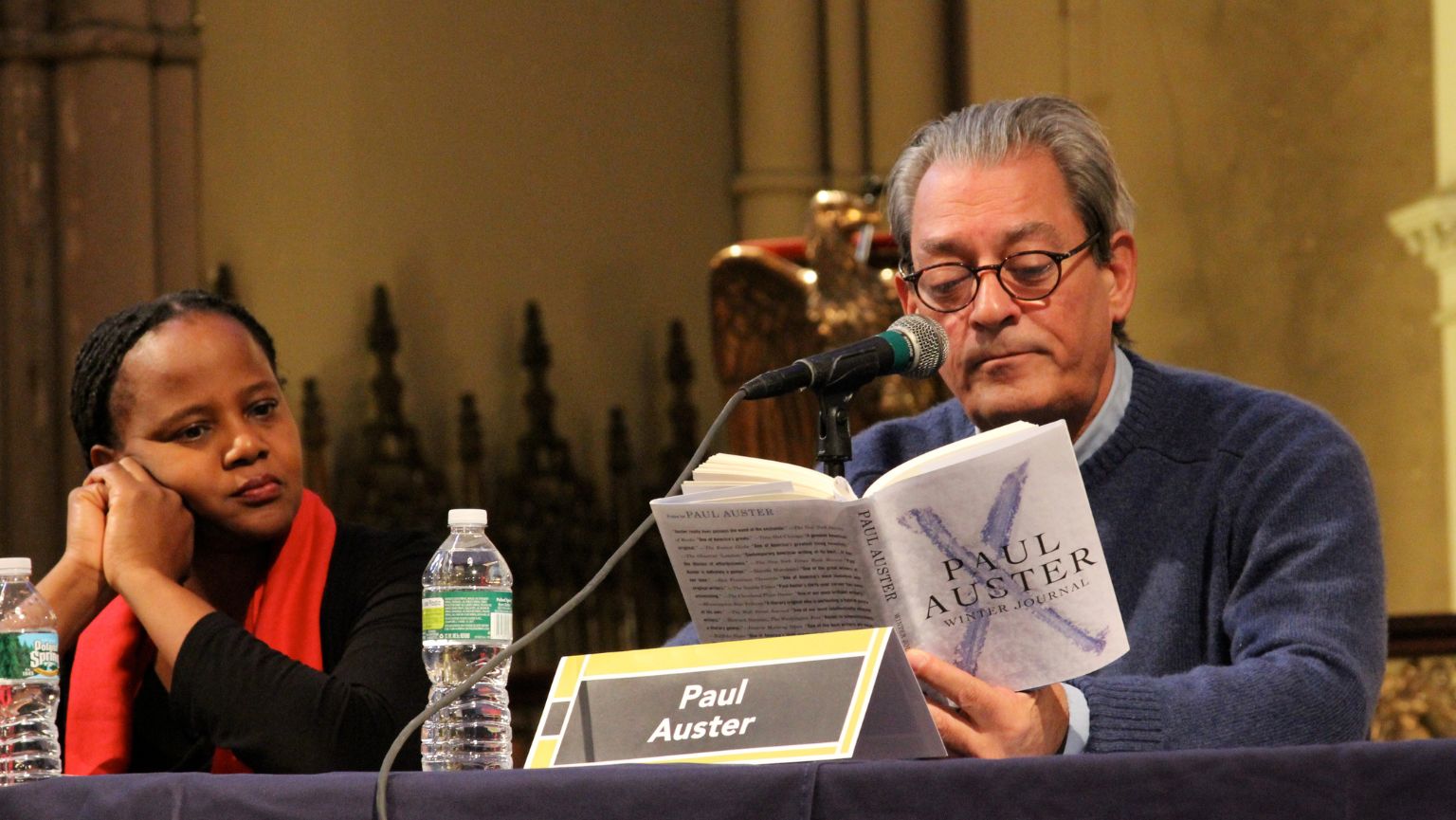(Kampala, Uganda). Qui la terra è rossa, il cemento non c’è. La strada è piena di boda-boda, delle moto-taxi molto comuni nei Paesi centroafricani, che ti fermano ogni due metri per sapere se vuoi un passaggio e poi ripartono, per andare chissà dove. È una città caotica: si respira a fatica per il troppo smog, c’è un continuo suono di clacson che rimbomba. Le case sono tutte basse, è pieno di spianate di terra in cui non c’è nulla. Dalle strade principali si diramano stradine più piccole, in cui la povertà diventa un elemento quotidiano e normale, che chiamano ghettos. Qui le case sembrano costruite in luoghi casuali, ad altezze diverse, con materiali di fortuna. Le vie sono piene di persone, bambini e adulti. “Hi, how are you?”, mi salutano tutti coloro che incontro, guardandomi con interesse misto a diffidenza.
“In Canada ci sono tantissime persone ricche, mentre tu sei il nulla, non vali niente. E poi perché dovrei andare in un Paese in cui puoi vedere solo persone bianche?”. Benjamin ha quasi 50 anni, una parlantina irrefrenabile e una cicatrice sul naso procuratagli dalla polizia sudanese dopo essere scappato dall’Eritrea a poco più di 20 anni. Originario dell’Eritrea, vive in Uganda, a Kampala, da ormai più di due decadi. Per un po’ ha cercato di andare in Canada, una delle mete principali dei rifugiati che arrivano in Uganda, ma proprio quando aveva ottenuto il ricongiungimento familiare con la sorella che si trovava già lì ha rinunciato. Benjamin, come tanti altri suoi connazionali, ha lasciato il suo Paese ed è arrivato in Uganda per poi fare richiesta di asilo in Europa o nell’America del Nord. Ma lui, come tanti altri, alla fine ha deciso di rimanere. E vive la sua vita trascorrendo le giornate a Kampala, nel quartiere di Kabalagala, una zona della capitale abitata e frequentata da molti rifugiati di altri Paesi africani che ormai vivono stabilmente lì, avendo trovato in Uganda una pace la cui assenza li aveva portati ad abbandonare la loro casa.
L’Uganda è il Paese con il maggior numero di rifugiati in tutta l’Africa e il terzo in tutto il mondo, dopo Turchia e Pakistan. Sono più di un milione e mezzo i rifugiati presenti nel territorio ugandese a luglio 2023, stando ai dati rilasciati dall’Unhcr. Eppure, l’Uganda è un Paese molto povero, con un reddito annuo inferiore ai 700 dollari e un governo autoritario che ha destato l’attenzione dei media occidentali per le strette sui diritti civili degli ultimi anni. Come può una nazione del genere avere un sistema di accoglienza considerato come un modello da esportare in tutto il mondo?
“L’Uganda è storicamente un Paese che offre rifugio a chi scappa dalla guerra. Inoltre, il governo ugandese di Museveni ha capito una cosa fondamentale, che noi Paesi occidentali ancora non riusciamo a capire: un rifugiato accolto diventa un consumatore del proprio Stato e, in alcuni casi, anche un produttore. Questo chiaramente cambia le carte in tavola, perchè il rifugiato non viene visto come un fardello ma, al contrario, come una risorsa”, commenta Paolo Giambelli del programma Aics (Assistance to Individuals in Crisis Situation), gestito dall’ambasciata italiana in Uganda.
Un po’ tutti abbiamo in mente il “modello Riace”, inventato in un piccolo comune calabrese che ha assunto il volto del suo sindaco, Mimmo Lucano, nel quale i rifugiati che arrivavano ricevevano una casa abbandonata da anni e un lavor…