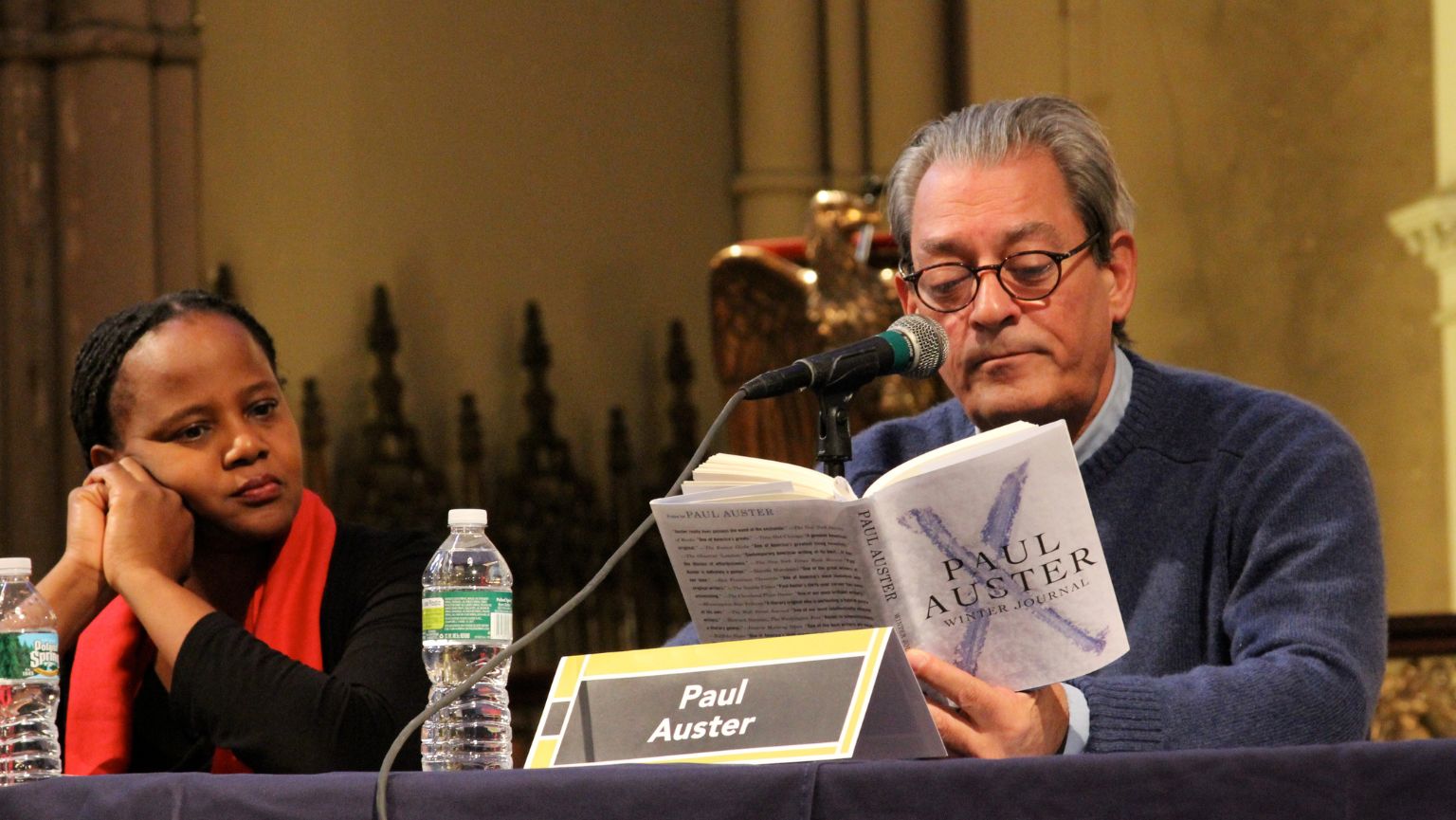L’ateneo sulla collina
Givat Ram, letteralmente “la collina di Ram”, è un quartiere che si sviluppa in maniera caotica su un’altura all’estremità occidentale dell’odierna Gerusalemme. Qui hanno sede diversi ministeri governativi, la Knesset, il Parlamento israeliano, parte dell’Università Ebraica e la Banca d’Israele. Gli israeliani di una certa età, provenienza etnica e background socio-economico hanno maturato una notevole nostalgia per questo luogo. La collina di Ram fa inoltre una brevissima, bucolica apparizione nel primo e più celebre romanzo di Amos Oz, Michael mio, pubblicato nel 1968. Qui è dove: «Intorno ai nuovi uffici del palazzo del primo ministro, pascolano greggi»[1]. Oggi le pecore non si vedono più e i pascoli sono da lungo tempo scomparsi. Hanno lasciato il posto a un elaborato sistema di autostrade, cancelli metallici, ponti sospesi e un roseto alquanto grazioso.
È altamente improbabile che, quando Oz diede alle stampe il suo libro, nei pressi dell’ufficio del primo ministro vi fossero ancora delle pecore. Tuttavia, esse pascolavano su questa altura all’epoca in cui qui sorgeva Sheikh al-Badr, un villaggio rurale palestinese. Alcune delle sue case sopravvivono tuttora, proprio accanto agli hotel americani frequentati dai membri della Knesset che non risiedono a Gerusalemme. Il villaggio era stato gradualmente inghiottito dalla città, diventando parte dell’agglomerato urbano fino a quando non fu etnicamente ripulito dalle forze israeliane nel 1948. Si trattava di un luogo famoso poiché si affacciava su uno dei punti più noti di Gerusalemme: la valle della Croce. È qui che, secondo la tradizione, si ergeva l’albero il cui legno fu usato per costruire la croce di Cristo ed è per questo che, come si racconta, in quel punto i monaci greco-ortodossi edificarono un imponente monastero ancora presente, sebbene circondato dai nuovi quartieri ebraici e dalle vie di circonvallazione.
A ovest del monastero si trova uno dei due campus principali che costituiscono l’Università Ebraica di Gerusalemme. Fu costruito su un terreno confiscato a Sheikh alBadr e poi venduto all’università dal Custode israeliano delle Proprietà degli Assenti (cioè terre teoricamente in attesa di una decisione circa il loro futuro, ma in realtà vendute a qualsiasi persona o impresa ebraiche disposte a pagare un prezzo ridicolo)[2]. Fino al 1948 l’università sorgeva sul monte Scopus, il quale divenne poi “terra di nessuno”, ossia un’isola all’interno della parte giordana della città e perciò inaccessibile. Dopo la guerra, nel giugno 1967, molti dipartimenti del campus di Givat Ram furono trasferiti nuovamente nel vecchio campus sul monte Scopus, che in seguito venne notevolmente ampliato sui terreni confiscati ai palestinesi.
All’incirca nello stesso periodo, a nord del recente complesso universitario fu eretta la nuova dimora del governo israeliano. Malgrado gli edifi…