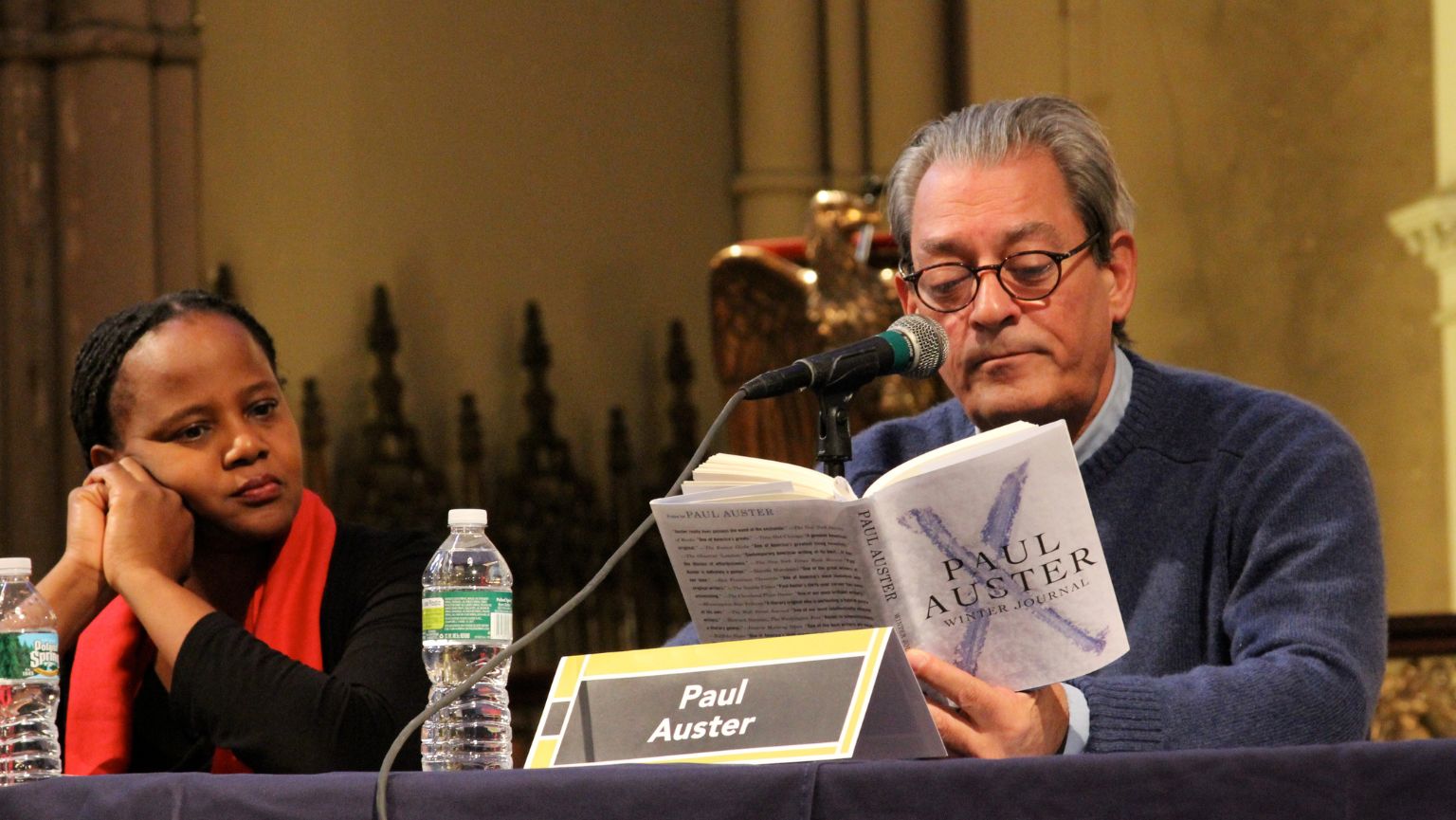Il testo che segue è la trascrizione del dialogo, moderato dalla direttrice di Left Simona Maggiorelli, tenutosi a Reggio Emilia nel corso delle Giornate della laicità, 8-12 giugno 2022.
Simona Maggiorelli: Stasera parliamo di cancel culture e politicamente corretto a partire da un libro, Non si può più dire niente?, edito da UTET. Si tratta di un volume collettaneo in cui si confrontano tanti punti di vista diversi su questi due temi che sono di grandissima attualità. Federica D’Alessio e Raffaele Alberto Ventura sono due degli autori e partirei chiedendovi di introdurci in questo tema che è così complesso, cercando innanzitutto di distinguere questi due concetti: che cos’è la cancel culture e che cos’è il politicamente corretto?
Federica D’Alessio: Si tratta di due fenomeni piuttosto diversi, ed entrambi non nuovissimi alla radice, ma certamente nuovi nella forma che hanno assunto negli ultimi anni. Entrambi i fenomeni hanno avuto origine negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il politicamente corretto, dal mio punto di vista non mi pare che ci sia molto da dire. Si tratta infatti di una questione che riguarda innanzitutto l’uso del linguaggio e l’attenzione che poniamo a come ci esprimiamo, soprattutto quando parliamo delle vite concrete delle persone. Il dileggio, il motteggio e anche l’offesa hanno sempre fatto parte della cultura europea, ma non possiamo nascondere che spesso si tratta di forme di uso (e abuso) del potere, a volte con intenzioni provocatorie, bonarie, a volte con intenzioni esplicitamente prepotenti. Il politicamente corretto si è affermato come esigenza di un linguaggio più attento, che mette in discussione questa espressione del potere. Un fenomeno che ha innescato la reazione di chi, penso per esempio al duo di comici Pio e Amedeo, pretende la “libertà” di utilizzare un linguaggio greve e offensivo e, di fronte a chi fa notare che si tratta appunto di linguaggio offensivo, lamenta appunto che “non si può più dire niente”. Personalmente non sono molto interessata a questo aspetto. Mi pare abbastanza ovvio che sia utile mettere un’attenzione maggiore a come si usa il linguaggio anche perché penso che qualunque concetto possa essere espresso anche in maniera molto dura, molto schietta, senza dover ricorrere a un linguaggio offensivo.
Altra cosa però – e qui ci spostiamo verso la cancel culture – è se a offendere non è il modo in cui le idee vengono espresse ma le idee stesse. Negli Stati Uniti, e sempre più spesso anche in Europa, si sta infatti diffondendo l’abitudine di protestare in maniera anche estremamente veemente, a volte persino violenta, quando persone propongono alla discussione punti di vista che vengono considerati offensivi non per il linguaggio con il quale vengono espressi, bensì per i contenuti stessi di quello che si dice. Qui la questione è un po’ diversa e merita una riflessione. Perché zittire qualcuno perché quello che pensa mi offende, a mio avviso non è legittimo. Anziché porsi in ascolto e, se del caso, contestare nel merito quello che viene detto, si fanno pressioni affinché a personalità che propongono un punto di vista considerato “problematico” (parola magica, che a ben vedere non significa assolutamente nulla) venga impedito di esprimersi. E si fa talmente tanto rumore che appuntamenti vengono c…