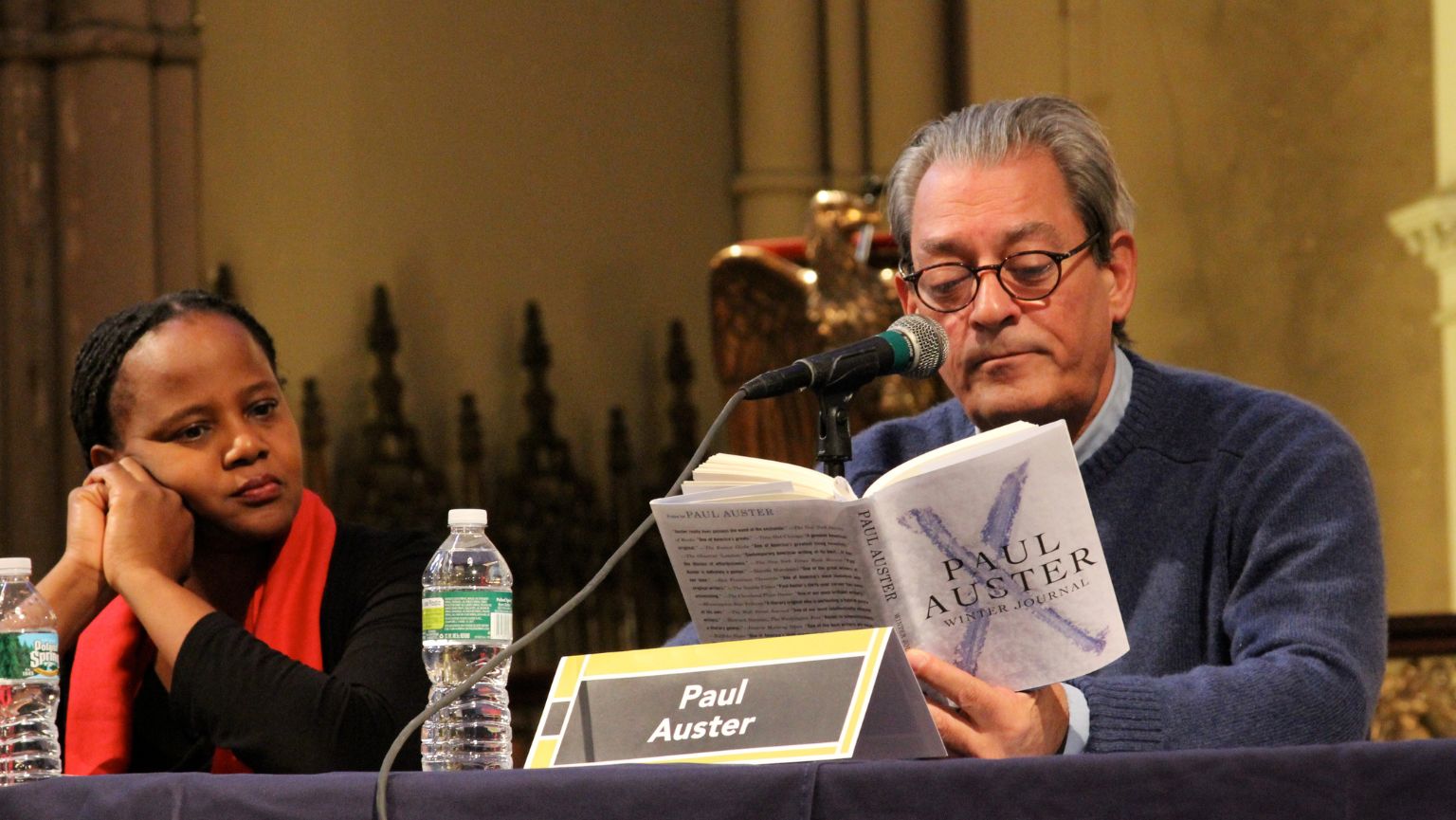Gli anni ’50 del secolo scorso sono quelli che si lasciano alle spalle la guerra, sono prosperi in un pezzo consistente d’Europa, Gran Bretagna in testa. È corsa all’acquisto della TV, già a partire dalla trasmissione BBC dell’incoronazione della Regina del 1953: oltre Manica la vedono in venti milioni. Ma è una società ancora avvitata su dettami conservatori, la famiglia è intesa come monomero costitutivo – ed esclusivo – della comunità, il benessere economico non sembra intaccare certi paradigmi del perbenismo borghese britannico. La musica è ancora, in parte, quella delle grandi orchestre, per i giovani c’è il rock&roll d’oltre oceano, cui, al limite, si contrappone lo skiffle che si ascolta nei pub, un coacervo di blues, folk, swing suonato con strumenti autocostruiti da musicisti rigorosamente autodidatti. È un mondo che sta stretto ai giovani inglesi e gli anni ’60 sono quelli in cui riescono a riprendersi i propri spazi, a dettare l’agenda delle grandi trasformazioni sociali e lo fanno attraverso forme d’aggregazione sempre più libere. Veicolo formidabile di questo processo sono le nascenti band del British Pop, Nelle principali città inglesi i gruppi sono migliaia, influenzati dal sound americano di formazioni come quelle di Buddy Holly and the Crickets, di Chuck Berry. Formazioni essenziali, un paio di chitarre, basso e batteria, ritmi incalzanti come già si ascoltavano nei locali tedeschi, canzoni brevi, giri armonici semplici ma carichi d’energia. Nella sola Liverpool si contano circa 350 band che animano le serate trasgressive dei giovani nei club e nelle sale da ballo. Ci sono schiere crescenti di fan che individuano nella musica e nei musicisti lo strumento di emancipazione più potente. Fra quelle piccole band c’è anche quella di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best. Avevano battuto per un po’ i palchi in Germania, s’erano formati da quelle parti, avevano fatto gavetta, e nel 1962 erano nuovamente a Liverpool. Qui rivedono molto della loro presenza scenica, del modo di suonare, lo adeguano ai tempi che preludono alla British Invasion, la risposta vincente al sound americano di quegli anni. Cominciano a suonare al Cavern Club, un locale non troppo distante dal negozio di dischi del manager Brian Epstein che ne sente parlare e non perde l’occasione per andare ad ascoltarli rimandone seriamente colpito. Epstein ha occhio lungo, vende dischi, conosce i gusti dei giovani: in quei quattro coglie qualcosa di dirompente. Li propone dapprima alla Decca per un provino che va male a causa di una scelta poco felice del repertorio. Non s’arrende e torna alla carica con la EMI, che invia il produttore George Martin ad ascoltare le cose del gruppo in una storica audizione. Dopo tre mesi, The Beatles hanno un contratto e, il 4 settembre 1962, si ritrovano nella sala d’incisione di Abbey Road, senza Pete Best però, troppo scontroso e poco incline a fraternizzare con il resto della band, nemmeno propenso ad adeguare look e stile di vita a quanto richiesto dal contesto e dal nuovo corso del gruppo. Alla base della rottura pare ci fosse anche l’invidia degli altri tre per come il batterista catalizzava un po’ troppo l’attenzione del pubblico femminile. Al suo posto viene scelto Ringo Starr che gli altri conoscono per averlo già incontrato in Germania come musicista nel gruppo Rory Storm and the Hurricanes, pure perché, talvolta, aveva sostituito Pete Best. Martin condivide la scelta ma, al termine della prima registrazione del singolo Love Me Do, creatura del duo compositivo Lennon-McCartney, Ringo non pare all’altezza. Viene dunque chiamato a sostituirlo il turnista Andy White, e a Ringo non tocca che sostenere la ritmica al tamburello. Nella successiva registrazione di P.S. I Love You gli vengono invece messe in mano le maracas. Tuttavia, il singolo Love Me Do viene pubblicato nella prima versione, quella suonata proprio da Ringo. Il disco ha un discreto successo, raggiunge il diciassettesimo posto nelle classifiche, ma non certo pare il preludio per un futuro spumeggiante della band. Si dice che la EMI non abbia fatto molto per promuoverlo adeguatamente. Nulla, in un certo senso, lascia intravedere che i quattro di Liverpool sarebbero sopravvissuti al tritacarne dell’industria discografica di quegli anni. Al massimo si guadagnano qualche sprazzo di popolarità in più nei locali di Liverpool, tuttavia, l’11 gennaio del 1963, i tipi della EMI concedono al gruppo una seconda possibilità con un nuovo singolo, ancora una composizione Lennon-McCartney, Please, Please Me. E così il primo disco dei Beatles se ne vola, tranquillo e beato, in cima alle classifiche dei dischi più venduti. Si può dire che all’alba di sessant’anni fa si stanno costruendo le fondamenta per la rock band più famosa ed importante di sempre.
Dopo quell’inatteso successo i tempi sono maturi per un album, non resta che tornarsene nei sacri studi di Abbey Road per inciderlo, pure senza perder tempo che quelli erano anni che macinavano le star parecchio in fretta. Battere il ferro finché era caldo, dunque, per non perdere l’onda d’urto del successo in cui George Martin aveva creduto sin dal principio. Così ci mettono solo quindici ore per registrare il nuovo album, praticamente lo fanno in presa diretta, buona la prima. Fanno anche di più, abdicano ad una pratica comune per quei tempi, quella di album mordi e fuggi, che sfruttano il successo di un singolo messo al centro di roba raccattata alla bene in meglio, spesso scritta da altri, al massimo qualche cover di brani già noti. Please, Please Me, l’album, era invece una cosa “seria”, con gran parte dei pezzi – a cominciare dai due singoli, Love Me Do e quello che dà il titolo al disco – opera del duo Lennon-McCartney, che irrompono sulla scena musicale con …