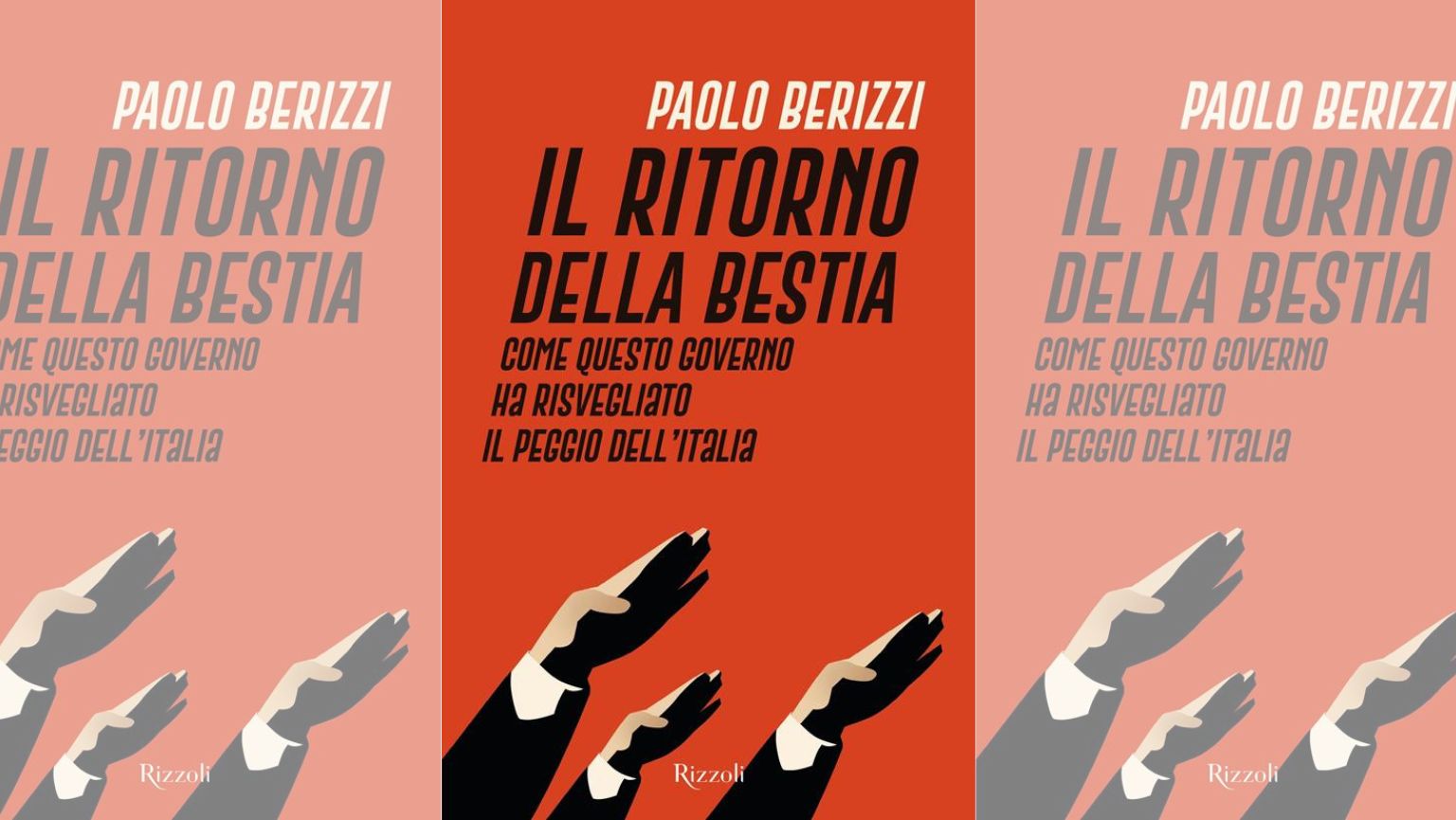È giusto distruggere o abbattere una statua? Alcuni credono di no perché “c’è in gioco la storia”. È come se abbattendo una statua ci si volesse liberare di una parte della storia. La si volesse cancellare, negare. Reinterpretare con le nostre categorie di contemporanei. È davvero così? Forse qualsiasi considerazione sull’abbattimento delle statue dovrebbe partire da una riflessione sulla natura della storia, dell’uomo e delle statue stesse. Partirei da quest’ultime, mi sembra la cosa più facile.
Perché si costruiscono le statue? Per commemorare una persona. Non solo per questo, ma soprattutto per questo. Riteniamo che una certa persona meriti stima duratura. Oppure lo ritiene la persona stessa, se è un dittatore. Perché spesso le statue se le costruiscono i tiranni.
Non ci sono più statue di Mussolini in Italia, ma neppure di Francisco Franco in Spagna. E neppure di Lenin. E questo nonostante esistano di certo seguaci di tali signori ancora oggi. In una democrazia, però, la loro voce non può superare quella di chi la difende. Ma una democrazia che impedisca ad alcuni di erigere delle statue ai loro beniamini politici, che oggi sembrerebbero inoffensivi dato che sono morti, è una democrazia vera, solida? O si potrebbe invece definire una democrazia che esercita la sua dittatura, la cosiddetta dittatura della maggioranza ad esempio, su certe idee ormai inoffensive, e comunque poco pericolose? Ma tali signori ormai morti degni di statue sono davvero inoffensivi? Il fatto che abbiano ancora dei seguaci sembrerebbe suggerire il contrario, ed è questo il punto vero che la democrazia intende tener fermo? Che questi seguaci cioè non possono usare le statue come simboli di qualcosa che può sempre tornare?
Prendiamo il caso delle statue dei signori razzisti e schiavisti del sistema sudista americano. Perché difenderne la presenza? Perché difendere il loro nome associato a basi militari o musei, o biblioteche pubbliche negli Usa? Le loro idee erano sbagliate, gravemente sbagliate, e sono state combattute – anche per ipocrisia, per carità – da un’altra parte che ha vinto, la parte nordista del paese. Esattamente come le idee di Hitler sono state combattute da altri ipocriti, ossia gli inglesi dell’impero razzista e gli americani dell’apartheid, ma alla fine sono state vinte perché ritenute ancora più pericolose, e poco utili allo status quo planetario. Il sistema sudista era stato ritenuto peggiore di quello nordista, e di sicuro poco utile per gran parte del paese, e alla fine ha perso. Poi è tornato a galla con l’aparthei…