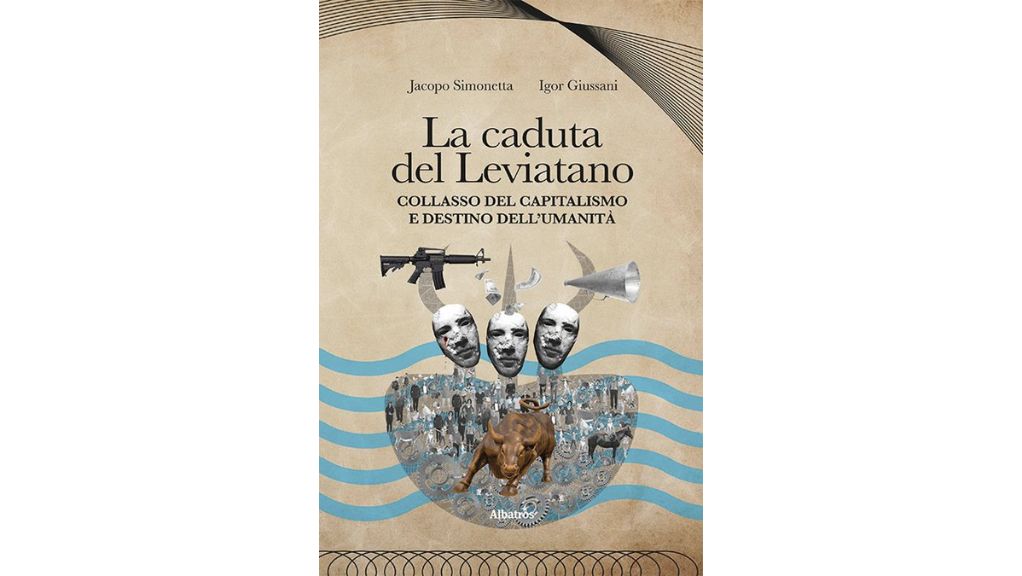Nell’articolo Nancy Fraser oltre Marx, il capitalismo che divora sé stesso, pubblicato il 23 giugno scorso su MicroMega+, il prof. Nicolò Bellanca cita tre libri accomunati dall’idea che il sistema capitalista sia entrato in una fase “cannibale” nel tentativo di sopravvivere alla propria decadenza. Tra tutti, il nostro La caduta del Leviatano (Gruppo Albatros Il Filo, 2023) ha ricevuto il giudizio più severo, essendo stato etichettato come «catastrofismo ideologico». Fatto curioso perché, in riferimento alle altre due opere, Bellanca fa ampio ricorso a concetti e metafore proprie del Leviatano.
Comunque, nella sua brevissima rassegna, l’autore non critica i due concetti-base del Leviatano, quelli di “quasi-superorganismo” e di “struttura dissipativa” applicati all’antroposfera (termine scientifico equivalente al nostro metaforico Leviatano). Si focalizza invece sulla nostra concezione del termine “collasso”, ma fraintendendola in quanto non comporta necessariamente un crollo repentino del sistema, bensì un degrado autocatalitico del medesimo, indipendentemente dalla scala temporale di riferimento. In altre parole, per noi “collasso” indica la contrazione/semplificazione di un sistema in cui le forzanti principali sono interne al sistema stesso.
Le nostre fosche prospettive si basano su diversi fattori, ma principalmente sull’analisi della struttura funzionale del capitalismo. Ben lungi dal “rovesciarsi”, le forze che hanno condotto alla crescita demografica, economica e tecnologica continuano a funzionare animate dalle medesime retroazioni positive di prima. Solo che, oramai, l’antroposfera ha fagocitato praticamente l’intero pianeta, cosicché non esiste più un “esterno” da cui attingere bassa entropia e su cui scaricare alta entropia. Riscaldamento del clima, estinzione di massa, crisi finanziaria globale del 2008 e pandemia sono solo alcune delle manifestazioni più evidenti di questo fatto.
Comunque, secondo Bellanca, l’analisi multidisciplinare di La caduta del Leviatano sarebbe inficiata dal fatto che «Gli autori attribuiscono la massima plausibilità allo scenario del collasso, in quanto confidano poco o nulla nelle tre maggiori variabili che, se modificate nella loro traiettoria, potrebbero condurre il sistema verso un declino lento, equo e poco traumatico: la tecnologia, l’affluenza (aumento di beni materiali) e la demografia. Al riguardo, tuttavia, i loro argomenti ci sembrano unilaterali».
In effetti, seguendo Mumford e altri, sosteniamo che lo sviluppo e la diffusione di nuove tecniche siano sempre stati strettamente dipendenti da una crescita quali/quantitativa dell’energia disponibile, una dinamica che si è progressivamente compromessa negli ultimi decenni. In secondo luogo, ogni progresso tecnologico ha sempre prodotto un aumento e non una riduzione dei consumi e dunque degli impatti antropici su scala globale; un fatto storicamente documentato fin dai tempi di Jevons, nonch�…