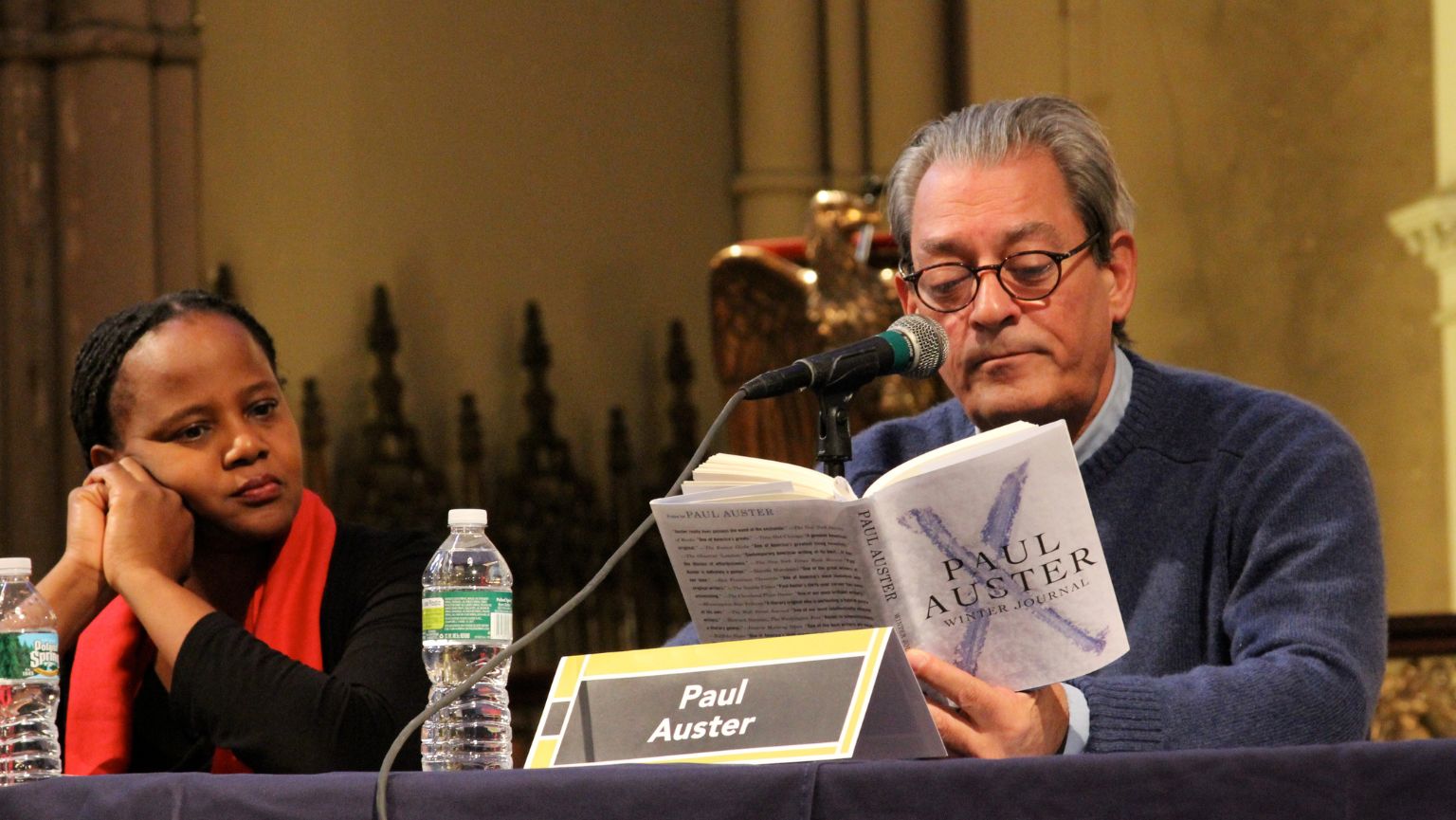Erano le 23 e 45 del 5 dicembre 2013. Jacob Zuma, allora presidente del Sudafrica, si rivolse alla nazione in diretta televisiva. Vestito di nero, alle spalle uno sfondo blu, pronunciò parole attentamente soppesate: “Il nostro amato Nelson Rolihlahla Mandela, il Presidente fondatore della nostra nazione democratica, se n’è andato. Si è spento serenamente, circondato dalla sua famiglia, intorno alle 20 e 50. Ora riposa. Ora, è in pace”.
Mentre le bandiere venivano poste a mezz’asta, la notizia della morte di Nelson Mandela rimbalzava su tutte le testate internazionali. Commemorazioni venivano organizzate in Francia e in Tibet, in Uruguay e in Cina, in Israele e in Palestina. Ai funerali di stato del 15 dicembre erano presenti 91 leader mondiali. Tra di loro Barack Obama e Raúl Castro che, sotto gli occhi attenti delle telecamere, si strinsero la mano in un gesto passato alla storia.
Succede così quando a morire è un mito. Smuove le coscienze, per poi dissolversi nel suo stesso racconto diventando allegoria. Nelson Mandela, figura-simbolo dell’ultima lotta africana contro la dominazione bianca, dell’antirazzismo e dell’integrazione tra i popoli, è stato uno dei grandi “padri della giustizia” del Novecento, insieme a Bob Kennedy, Martin Luther King e Gandhi.
L’ammirazione nei suoi confronti si è anzi spinta oltre, raggiungendo punte di idolatria. “Non sono un santo!”, ha ripetuto più volte. Ma l’idealizzazione crescente lo ha trasformato in una leggenda di bontà, compassionevole fino al soprannaturale. Facendogli, così, il più grande torto: nascondendo sotto una patina dolciastra il suo essere un grande statista e esponendo a inevitabili critiche le sue umane, dunque fallibili, caratteristiche.
Nato nel 1918 in una famiglia reale di etnia Xhosa, visse fin da subito il contrasto tra il suo sangue blu e la sua pelle nera che, nell’allora Unione Sudafricana dominata da una minoranza bianca, lo relegava nella scala sociale più bassa, nonostante la sua ascendenza. Alla nascita ricevette un nome profetico: Rolihlahla, l’attaccabrighe. Il secondo nome, il cristiano e molto inglese Nelson, gli venne attribuito alle scuole elementari da un insegnante del collegio coloniale britannico, non in grado o non desideroso di pronunciare gli appellativi locali. Il nome degli affetti, invece, era Madiba, in virtù del suo clan di appartenenza.
A 12 anni, divenuto orfano di padre, venne affidato al cugino Jongintaba Dalindyebo, un capo thembu da cui apprese l’arte di essere un leader, di ascoltare e far convergere opinioni diverse su una posizione comune. Dalindyebo si occupò di lui fino all’iscrizione allo University College di Fort Hare – la sola università per neri nel Paese – dalla quale fu espulso per essersi unito a una protesta studentesca. Il cugino-tutore organizzò allora per lui un matrimonio combinato. Mandela, ventiduenne ribelle e coraggioso, rifiutò. Fuggì nella seducente e trasgressiva Johannesburg, in un viaggio destinato a cambiare la storia.
Riuscì a laurearsi in giurisprudenza, iniziò a frequentare i militanti dell’African National Congress (ANC) e nel 1944 contribuì a fondarne l’ala giovanile, la Youth League, pacificamente attiva nella difesa della popolazione nera.
Lotta all’apartheid
A quell’epoca l’apartheid (da apart, separare) non era ancora formalmente in vigore, anche se la politica di segregazione razziale era largamente diffusa, praticata fin dalla nascita dello Stato sudafricano nel 1910. Prova ne è il Natives Land Act del 1913, che vietava alla popolazione nera, largamente maggioritaria (68 per cento) e già privata del diritto di voto, l’acquisto o l’affitto di terre al di fuori delle riserve (sette per cento del territorio nazionale, aumentato al tredici nel 1936).
Ma era solo questione di tempo. Mente negli altri Paesi si avviava il processo di decolonizzazione, nell’Unione Sudafricana, con la vittoria elettorale del Partito Nazionale nel 1948, l’apartheid divenne legge. I cittadini vennero classificati in quattro gruppi razziali (white, native, coloured, asian), fisicamente separati tra loro. I non bianchi vennero privati di ogni diritto.
Le posizioni di Mandela si radicalizzarono…