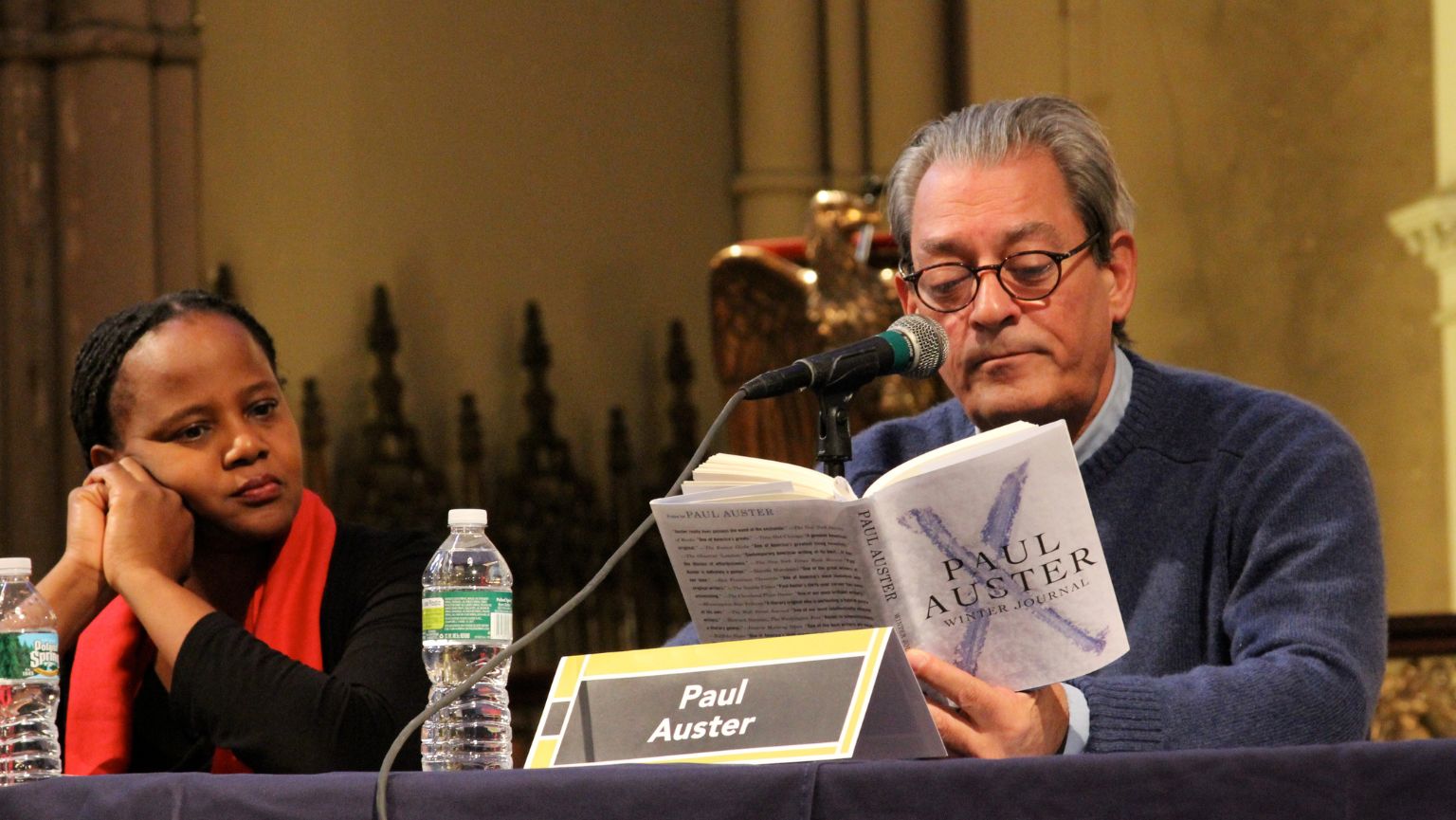Ogni anno, in vista delle Cop sul clima, il Conflict and Environment Observatory (Ceobs) calcola il Military Emission Gap, che mira a monitorare le emissioni riconducibili all’industria militare, le quali non vengono registrate o comunicate dai Paesi. Lo fa raccogliendo i dati più recenti dell’Unfccc, accanto a un’analisi dell’accessibilità dei dati condivisi dai ministeri della difesa dei singoli Stati, che vengono poi classificati rispetto a chi risulta più o meno trasparente. L’analisi di quest’anno, pubblicata in vista della Cop28, mostra come nessun paese abbia migliorato il proprio Military Emission Gap. La Norvegia è persino peggiorata rispetto al 2022: se l’anno scorso calcolava l’utilizzo di carburante sia delle strutture stabili sia dei mezzi mobili dell’esercito, oggi riporta soltanto le emissioni causate dai secondi. Quanto calcolato dalla Norvegia non si avvicina neanche lontanamente a quello che realmente consuma. Lo stesso calcolo molto parziale e distante dalla realtà viene effettuato dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dal Canada e da numerosi Paesi europei. Nel report del CEOBS di quest’anno si legge inoltre che Giappone, Irlanda e Nuova Zelanda non hanno proprio riportato le emissioni del loro settore militare all’Unfccc, nonostante abbiano calcolato parte delle emissioni nei singoli Ministeri della difesa. Questo significa che probabilmente sono perfettamente in grado di misurare l’impatto ambientale del settore militare, ma che l’Unfccc concede ai Paesi la libertà di non comunicarli. Si stima che l’impatto ambientale dell’industria militare corrisponda al 5,5% circa delle emissioni globali, ma dal momento che il calcolo delle emissioni del settore militare di un Paese viene comunicato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) su base volontaria, le informazioni accessibili al pubblico sono molto limitate se non del tutto assenti.
È pertanto importante contestualizzare la crescente presenza della Nato, del dipartimento della difesa statunitense e dell’industria militare in generale alle Cop in un quadro che a oggi risulta molto poco trasparente. Più trasparenti invece sono i bombardamenti sui territori e i loro effetti. Gli Stati Uniti danno priorità agli aiuti militari in Israele rispetto ai loro impegni sul taglio delle emissioni, e oltre alle incalcolabili ripercussioni umanitarie sugli abitanti della regione, l’impatto ambientale di una guerra come quella su Gaza non è equiparabile a nessun altro ambito economico o settore inquinante. Lo stesso vale per la guerra in Ucraina per mano di Putin, sulla quale alla Cop dell’anno scorso si è tenuto un dibattito per sottolineare la responsabilità della Russia per gli effetti devastanti che la guerra sta avendo sull’ambiente, sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare in Ucraina. Un gruppo di ricercatori