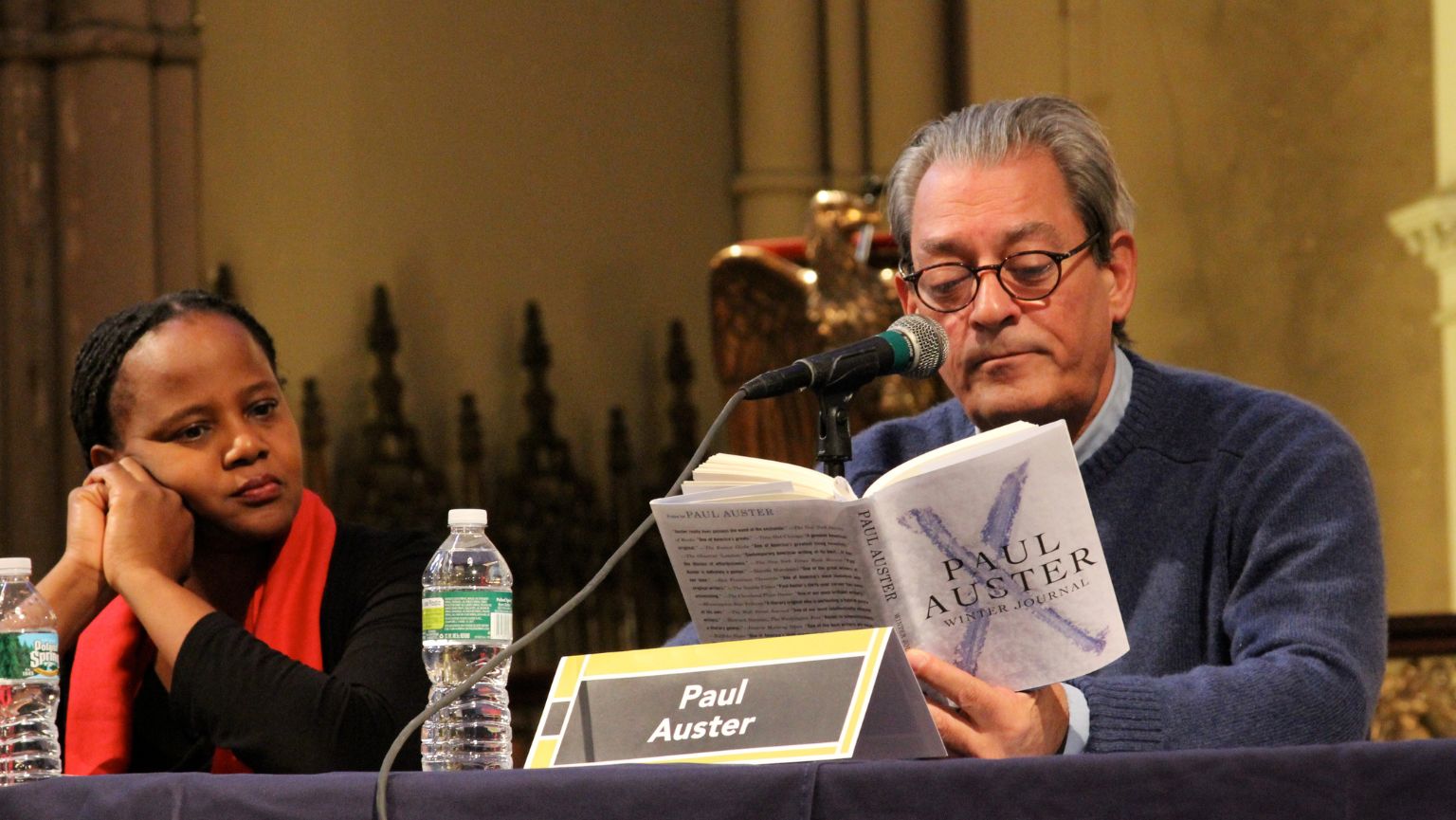Come in Marx, uno dei capisaldi della teoria della rivoluzione di Lenin era la fase iniziale della rivoluzione sociale, ossia il rovesciamento e l’abolizione dello Stato politico, un’istituzione millenaria della società umana. La questione dello Stato, «questione centrale di qualunque rivoluzione», aveva interessato Lenin sin da quando era studente e si era già affermata nel pensiero rivoluzionario russo premarxista nelle sue varie forme storiche (soprattutto fra i bakuninisti e altri anarchici). Tuttavia, Lenin sottolineava le caratteristiche di classe, così come la portata sociale e universale della rivoluzione, in particolare affrontando la nozione di utopia «contadina» e «nazionalista».
Rispetto a Lenin, Martov aveva esaminato l’eredità di Bakunin in modo più acuto, formulando degli argomenti in un certo senso più «sottili» contro l’anarchismo. In un articolo scritto nel 1910, Martov aveva rivelato che, dopo essere uscito sconfitto dalla polemica con Marx portata avanti all’interno dell’Internazionale negli anni sessanta del XIX secolo, e dopo essere diventato la «guida» spirituale dei movimenti anarchici, Bakunin aveva accolto le tesi economiche di Marx, cioè la sostanza del Capitale, ovvero la sua conclusione, vale a dire: la necessità dell’«espropriazione degli espropriatori». Si era giunti a un cul-de-sac teorico-metodologico e pratico-politico perché, analogamente a Proudhon, Bakunin «contrapponeva l’organizzazione economica della società alla sua organizzazione politica»: secondo lui, è indispensabile conquistare l’uguaglianza e la giustizia nella sfera economica, mentre la causa principale della disuguaglianza sociale è insita nella sfera della politica, dove governa la forza bruta. Questa è la ragione per cui Bakunin e gli anarchici consideravano lo Stato il loro nemico principale e vedevano nella sua distruzione la condizione sine qua non per la liberazione della società. In altre parole, Martov dimostrò che causa ed effetto erano stati invertiti. La consapevolezza di questa inversione portò alla convinzione che il marxismo dovesse scalzare l’anarchismo dal movimento rivoluzionario.
Indubbiamente, la concezione anarchica del mondo in generale e della politica in particolare (che partiva dalla considerazione che la sfera della politica si sarebbe potuta trascurare e distruggere in un sol colpo, come se la sfera politica e lo Stato stesso non siano portatori dei rapporti socio-economici capitalistici) aveva attecchito in Russia e soprattutto in Ucraina, negli ambienti contadini che si opponevano alla coercizione dello Stato, ma aveva aperto brecce anche nel movimento operaio. Il punto principale era che essi concepivano la possibilità e la necessità della rivoluzione socialista esclusivamente in termini di «rivolta popolare», senza tener conto della sisifea fatica organizzativo-intellettuale che una tale rivoluzione comportava. Dalla fine del XIX secolo, dunque, era divenuto sempre più evidente che l’anarchismo russo non fosse in grado di comprendere le nuove problematiche della società, ma aveva preparato il terreno per altri movimenti rivoluzionari anticapitalistici e allo stesso tempo aveva risvegliato dal letargo strati sociali relativamente ampi.
Nella storia delle rivoluzioni ciò che interessava maggiormente Lenin era come gli operai riuscissero, foss’anche solo per una settimana o un mese, ad assumere il controllo della propria vita. Approfondì la questione in modo scientifico, concentrandosi sulle peculiarità dello sviluppo dello Stato in Russia. Ma non era in alcun modo interessato alle questioni relative al funzionamento dello Stato borghese o alla sociologia istituzionale dei partiti e dei meccanismi burocratici, neppure nell’interpretazione di Max Weber. La sociologia dello Stato borghese era per lui una scienza finalizzata alla difesa, all’apologia di questo Stato, sostenuta da argomentazioni scientifiche. Lenin studiava il moderno Stato borghese come forma suprema dello sfruttamento economico e intellettuale. Secondo la sua impostazione teorica, il parlamentarismo borghese, il suo malfunzionamento e il suo intero sistema manipolatorio erano collegati alle – e derivavano dalle – più moderne forme della produzione capitalistica. Per comprendere storicamente questa problematica, occorre ricordare che negli anni 1910-1920 il parlamentarismo borghese aveva ancora poco in comune con la sua forma attuale ed era caratterizzato da tratti palesemente antidemocratici, come ad esempio la natura censitaria del diritto di voto e altre sue limitazioni. A titolo di esempio ricordiamo che in Inghilterra le donne hanno ottenuto il suffragio universale solo nel 1928. Come già spiegato nel capitolo II, durante i suoi studi Lenin aveva rivolto l’attenzione ai continui e inevitabili conflitti tra capitalismo e democrazia, che contengono in sé la fondamentale contraddizione tra uguaglianza giuridica e disuguaglianza socio-economica. Il sistema capitalista tentava di risolverla con l’aiuto di un sistema pervasivo di «venalità», «corruzione» e «truffe».
Nella visione di Lenin, la differenza fondamentale tra imperialismo e capitalismo pre-monopolistico consisteva nel fatto che, con il primo, «il potere della Borsa si espande» e le grandi banche si fondono con la Borsa assorbendola; il capitale mette sotto controllo la sfera della politica, come se fosse una merce o un altro qualunque fenomeno di mercato. Lenin era ovviamente consapevole del fatto che la corruzione della democrazia borghese fosse soggetta a regolamentazione normativa, e che quindi non poteva essere illimitata. Allo stesso tempo, tuttavia, sottolineava come questa corruzione legalizzata derivasse dalla ricchezza, perché per la ricchezza «risulta pienamente realizzabile il suo predominio in ogni repubblica democratica mediante la corruzione e la Borsa […] che è una repubblica politicamente indipendente». Per Lenin quindi, la democrazia borghese non era libertà, ma «libertà di corruzione». Nel settembre del 1917 formulò la questione in questi termini:
“I capitalisti (e dietro a loro, per stupidità o per inerzia, molti socialisti rivoluzionari e menscevichi) chiamano «libertà di stampa» l’abolizione della censura e la libertà per tutti i partiti di pubblicare qualunque giornale. In realtà questa non è libertà di stampa, ma libertà per i ricchi, per la borghesia, d’ingannare le masse popolari oppresse e sfruttate”. (“Come assicurare il successo dell’assemblea costituente (Sulla libertà di stampa”), in LOC, XXV, pp. 356-60: 357).
Allo stesso tempo, da un punto di vista storico, Lenin considerava la democrazia borghese come massima forma di dominio del capitale. In effetti, a suo avviso l’unica ragione per parlare dei vantaggi (sempre che si debba farlo) del «venale e marcio parlamentarismo della società borghese» era in quanto esso apre ulteriori opportunità allo sviluppo del movimento operaio, che conquista così un margine di manovra più ampio rispetto a quello che ha con i regimi autoritari e apertamente dittatoriali. Il parlamentarismo borghese, in questo senso, rappresentava agli occhi di Lenin solo un «interesse storico», ma non aveva alcun futuro. Il re è nudo!
Nel periodo della rivoluzione le questioni puramente scientifiche non erano al centro degli interessi di Lenin. Inoltre, l’esperienza della prima guerra mondiale aveva reso evidente che il primo compito politico dovesse essere lo smascheramento delle democrazie parlamentari in quanto regimi responsabili dello spargimento di sangue a livello mondiale. Di conseguenza, Stato e rivoluzione non era semplicemente una «chimera», ma – permeato come era di un pensiero fondamentalmente orientato al futuro – comprendeva una critica oggettiva del parlamentarismo che dopo il 1917 non si poteva semplicemente depennare dall’agenda politica.
Nel 1917 non si parlava ancora di «globalizzazione», ma piuttosto del nuovo sistema di dominio affermatosi a livello nazionale e sovranazionale, analizzato sotto il profilo economico e politico; i temi erano l’imperialismo, il potere dei monopoli e del capitale finanziario. Come ampiamente riconosciuto, lo Stato tipico di questo nuovo ordine, proprio nel periodo della prima guerra mondiale aveva acquisito una nuova funzione: era divenuto il principale organizzatore e attore dell’economia nazionale; era quel tipo di «mostro» pronto a distruggere qualunque cosa in nome di determinati interessi. In questo senso è importante l’ultima frase di Stato e rivoluzione, perché espone l’argomentazione che ha portato all’appello finale alla rivoluzione:
“La deformazione e la congiura del silenzio interno al problema dell’atteggiamento della rivoluzione proletaria nei confronti dello Stato non potevano mancare di esercitare un’immensa influenza, in un momento in cui gli Stati, muniti di un apparato militare rafforzato dalle competizioni imperialiste, sono diventati dei mostri militari che mandano allo sterminio milioni di uomini per decidere chi, tra l’Inghilterra e la Germania, tra questo e quel capitale finanziario, dominerà il mondo”. (LOC, XXV, pp. 461-2)
Rispetto ai periodi precedenti, questo dominio mostrava chiari segnali di una concentrazione del potere nella sfera politica. In relazione a ciò, Lenin prese spunto non solo dalla crisi generale del sistema capitalista, ma anche dalle concrete aree di «anomalia» nel funzionamento della democrazia borghese (burocrazia, corruzione, parassitismo ecc.), che secondo lui avrebbero potuto rinforzare le probabilità di una svolta rivoluzionaria. La posizione di Lenin teneva conto della varietà delle forme di Stato, ma, da propagandista e teorico della rivoluzione qual era, ne ricercava i punti in comune: «Le forme degli Stati borghesi sono straordinariamente varie, ma la loro sostanza è unica: tutti questi Stati sono, in un modo o nell’altro, ma, in ultima analisi necessariamente, una dittatura della borghesia» (Ibid., p. 390), il che esclude la possibilità di «ristabilire» la forma comunitaria della proprietà al posto della proprietà privata capitalistica sfruttatrice, o accanto ad essa. Quindi, secondo questa interpretazione, «la forma di governo parlamentare» non è altro che una lotta fra gruppi di potere per la spartizione del «bottino» (cariche di prestigio, posizioni economiche ecc.). Sotto il profilo giuridico e politico questo sistema non può essere messo in discussione, motivo per cui nella teoria di Lenin le democrazie borghesi sono enfaticamente presentate come delle dittature, e questa loro particolarità non può essere eliminata senza una rivoluzione, senza la «demolizione della macchina statale burocratico-militare».
Dopo l’esperienza della prima guerra mondiale, Lenin maturò un’opinione ancora più critica della democrazia parlamentare rispetto al passato, perché vi vedeva soltanto l’espressione istituzionale degli interessi della finanza e del capitale, un sistema di manipolazione e di inganno che serviva a fiaccare la resistenza dei lavoratori salariati nell’interesse della produzione capitalista e del profitto. Questo fu uno degli argomenti decisivi a favore della rivendicazione di sostituire i «chiacchieroni » parlamentari che si riunivano sopra la testa del popolo con «organismi elettivi operativi e revocabili» sulla base dell’esperienza della Comune di Parigi.
“Le istituzioni rappresentative rimangono, ma il parlamentarismo, come sistema speciale, come divisione del lavoro legislativo ed esecutivo, come situazione privilegiata per i deputati, non esiste più” (Ibid., p. 400).
Analizzando il funzionamento dello Stato borghese, Lenin giunse alla conclusione che la povertà e la miseria di fatto escludono la possibilità di godere delle garanzie giuridiche offerte dalla democrazia; e non solo perché i poveri non hanno la possibilità di «comprare» «i beni » della democrazia, ma perché
“gli odierni schiavi salariati, in conseguenza dello sfruttamento capitalistico, sono talmente soffocati dal bisogno e dalla miseria che «hanno altro pel capo che la democrazia», «che la politica», sicché, nel corso ordinario e pacifico degli avvenimenti, la maggioranza della popolazione si trova tagliata fuori dalla vita politica e sociale” (Ibid., p. 432).
Un argomento importante nel programma rivoluzionario e nella «filosofia » della liquidazione dello Stato come entità politica era l’eliminazione dello «Stato parassita», che avrebbe dovuto diventare il presupposto politico della «liberazione economica del lavoro». Quindi Lenin interpretava i concetti di Stato e libertà come diametralmente opposti.
Con in mente il rovesciamento rivoluzionario dello stato delle cose, nell’opuscolo Lenin poneva come obiettivo principale, in termini metodologici e politici, il superamento delle «illusioni opportunistiche» legate al parlamentarismo, cioè al revisionismo di Bernstein, e alle idee utopistiche degli anarchici. A suo avviso, i primi avevano abbandonato le idee di Marx in nome di uno «statalismo di mercato», mentre i secondi avevano «solo» perso di vista la prospettiva immediata. La socialdemocrazia ufficiale della Seconda Internazionale aveva sostituito il «rovesciamento » e la «distruzione» dello Stato borghese con lo slogan «Stato popolare» democratico e assistenziale, inteso come «correttivo» della democrazia borghese (Bernstein, Kautsky, Scheidemann), quindi uno Stato borghese di diritto (Rechtsstaat) guidato da un governo socialdemocratico. Per Lenin la democrazia era un concetto elastico, così come per Engels, il quale nel 1894 aveva affermato che nei suoi articoli degli anni settanta dell’Ottocento utilizzava «il termine “comunista” anziché “socialdemocratico”, poiché all’epoca persino i lassalliani si autodefinivano socialdemocratici». A differenza del pensiero borghese dell’epoca, Lenin si approcciava allo Stato non solo dal punto di vista politico, sociologico e giuridico-formale. Spesso faceva riferimento al fatto che gli apologeti dello Stato borghese lasciavano in ombra le funzioni «finanziaria», «economica», «capitalistica», «latifondista» dello Stato; ma sul versante rivoluzionario nessuno tranne gli anarchici – neanche l’ala contadina dei socialisti rivoluzionari, per esempio – comprendeva che la lotta contro lo Stato di per sé è inutile fino a quando le sue fondamenta economiche non vengano liquidate. Di conseguenza dichiarò che, tenuto conto della sua funzione economica e di classe, lo Stato poteva essere eliminato completamente solo «dopo la soppressione da parte delle classi per opera della rivoluzione socialista, come risultato dell’instaurazione del socialismo che porta all’estinzione dello Stato» (Ibid., p. 455).
Lenin trovò una posizione comune con gli anarchici sulla rivoluzione come «evento» e «necessità politica e teorica». Ciononostante, definì la rivendicazione anarchica della «completa e definitiva distruzione » dello Stato l’annichilimento dell’autodifesa della rivoluzione. Riferendosi a Engels, sottolineò che con la scomparsa dello Stato politico non scompaiono automaticamente l’autorità statale e le forme di subordinazione. Dopo tutto,
“prendete una fabbrica, una ferrovia, un piroscafo in alto mare, – dice Engels, – non è evidente che senza una certa subordinazione, e quindi senza una certa autorità o un certo potere, non è possibile far funzionare nemmeno uno di questi complicati apparati tecnici, fondati sull’impiego delle macchine e la metodica collaborazione di un gran numero di persone?” (Ibid., p. 411)
Lenin rilevò negli anarchici lo stesso errore che aveva evidenziato Engels, cioè il desiderio di «abolire lo Stato dall’oggi al domani» (LOC, XXV, p. 410). In altre parole, essi negavano la «dittatura del proletariato», il «periodo di transizione». Gli anarchici russi non avevano capito che l’«abolizione dello Stato» comincia nella produzione, nell’economia. Generalmente gli anarchici russi non erano mai andati oltre una concezione riduzionista del marxismo; non solo non accettavano la dottrina economica marxista, ma la ignoravano o etichettavano il pensiero marxista in relazione alla storia e alla teoria politica come una «teoria statalista». Oppure, contrapponevano gli obiettivi finali comunisti di Marx alla sua dottrina politica e sociale.
L’opera di Lenin fu trattata in modo analogo dagli anarchici russi. Invano bolscevichi e anarchici si erano trovati d’accordo sull’obiettivo dell’«anti-Stato», la loro temporanea cooperazione armata e le eroiche gesta della Machnovščina (l’esercito insurrezionale rivoluzionario di tipo anarchico localizzato nel Sud-est dell’odierna Ucraina) contro Denikin. Non appena si era posta la questione di una nuova organizzazione statale, della formazione di una nuova gerarchia burocratica, dell’istituzione di una produzione centralizzata e della tradizionale divisione del lavoro, agli occhi degli anarchici i bolscevichi si erano trasformati in «traditori», mentre agli occhi dei bolscevichi gli anarchici erano diventati dei «banditi», la cui eliminazione militare era legata proprio al fatto che essi non riconoscevano la nuova autorità statale nei territori da loro controllati.
In questo modo, sulla base degli scritti di Marx ed Engels, coniugando la questione della rivoluzione con quella dello Stato, Lenin delineò i contorni di una sorta di tertium datur tra la socialdemocrazia riformista e l’anarchismo. Un importante merito teorico e politico di Lenin consiste nell’aver compreso che la borghesia russa e la «tremebonda» classe media in generale non sarebbero state in grado di stabilizzare né il vecchio sistema «semi-parlamentare» (con o senza zar), né il regime democratico borghese. A suo parere, questi tentativi di stabilizzazione avrebbero aperto la strada a dittature controrivoluzionarie nel caso in cui la rivoluzione fosse entrata in crisi o avesse subito una sconfitta.
Il fatto che Lenin abbia scritto Stato e rivoluzione in clandestinità, cioè dopo che il governo provvisorio aveva spiccato contro di lui un mandato di arresto in seguito ai «fatti di luglio», ha un valore simbolico. La democrazia borghese appena instaurata già era in crisi. Non sorprende quindi che a preoccupare Lenin nella sua capanna a Razliv fosse in primo luogo la questione del sistema istituzionale con cui la classe rivoluzionaria avrebbe sostituito la «demolita macchina statale», della quale in Russia restavano solo i rottami. Perciò individuò non nel modello russo, il soviet, bensì nel suo «prototipo», la Comune di Parigi, l’organo capace di porre in termini pratici la questione dell’obiettivo finale della rivoluzione proletaria. Il contenuto e lo scopo fondamentali della nuova forma di autogoverno sul modello della Comune, intesa come organizzazione economica e comunitaria, avrebbe dovuto essere, alla fine dei conti, l’abolizione delle disuguaglianze socio-economiche.
Non è un caso che in Stato e rivoluzione non compaia il concetto di partito. Questa assenza è stata spesso spiegata in modo poco chiaro, anche se è molto semplice. Per Lenin, nel socialismo autogestito le classi e i partiti non esistono più. È un comportamento poco scientifico da parte di coloro che – riferendosi al libro di Kautsky (La dittatura del proletariato) scritto nel 1918 e agli articoli di Martov – affermano che già a suo tempo Stato e rivoluzione era stato criticato per l’idea del sistema monopartitico. Queste critiche pregiudizievoli si riferivano alla realtà della Russia sovietica post-1917 e proiettavano sui precedenti lavori di Lenin la situazione venutasi a creare in seguito, come se lui fosse un velato sostenitore del sistema del partito unico già nel 1917. Non c’è dubbio che le argomentazioni politiche e teoriche di Lenin nel corso degli anni siano mutate sotto molti aspetti, ma infilare surrettiziamente il sistema di partito unico in Stato e rivoluzione significa o compiere una falsificazione storica, o non comprendere affatto il punto. La Rivoluzione d’Ottobre elevò i soviet a livello di alternativa al parlamentarismo, sia dal punto di vista teorico che pratico, anche se si tiene conto che i soviet, in quanto organo di autogoverno proletario, già nel 1918 avevano cominciato a infiltrarsi nelle nuove strutture del potere centrale e nella nuova gerarchia da loro definita che si andava gradualmente sviluppando. Per inciso, il sistema monopartitico non è mai stato introdotto giuridicamente, eccezion fatta per la Costituzione brežneviana del 1977, che per la prima volta proclamò il sistema sovietico un sistema monopartitico. All’epoca di Lenin, i partiti politici subivano generalmente sanzioni amministrative secondo la logica della lotta politica; queste erano motivate a volte con le condizioni di guerra, a volte con le attività controrivoluzionarie di questi partiti, ma non furono mai vietati a norma di legge costituzionale. Il sistema monopartitico effettivamente affermatosi intorno al 1921 non aveva legittimazione giuridica, ma fu il punto di vista al quale si atteneva anche Lenin e secondo cui la dittatura dei soviet, cioè la «dittatura della maggioranza (dittatura del proletariato) sulla minoranza», era politicamente legittimata dalla rivoluzione stessa. Ma le contraddizioni non tardarono a farsi sentire.