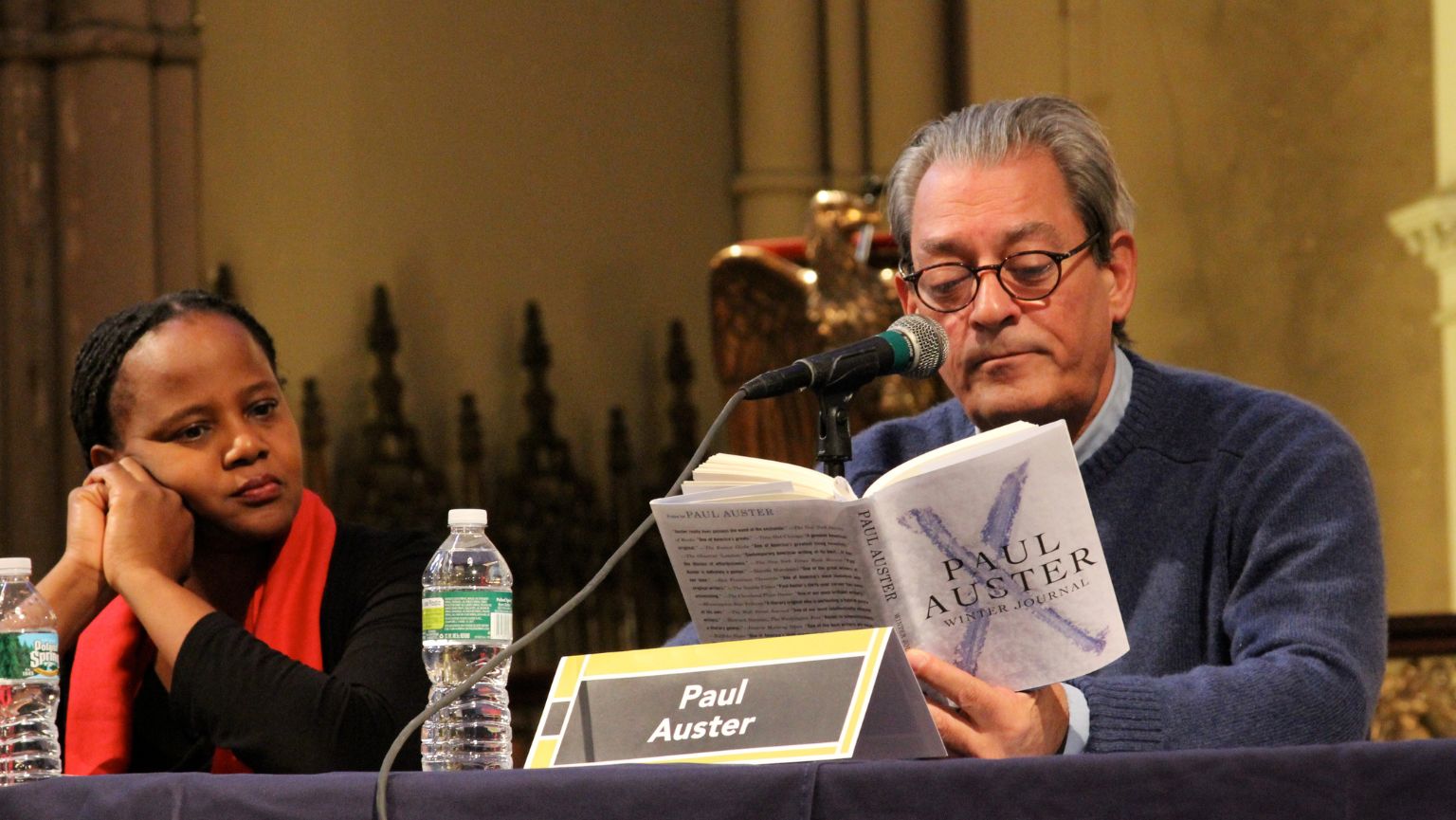Trent’anni fa, il 29 aprile del 1992, la rabbia per una decisione sentita come profondamente ingiusta, nonché come frutto del razzismo imperante nella società, dava vita a una delle proteste di strada più eclatanti che la storia statunitense ricordi. Circa un anno prima, il 3 marzo del 1991, un giovane tassista nero di nome Rodney King, dopo un inseguimento in macchina da parte della polizia, veniva fermato e – sotto la direzione di un quarto poliziotto – picchiato selvaggiamente da tre agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles. Da un appartamento poco lontano un videoamatore riprendeva la scena e qualche giorno dopo consegnava il filmato alla televisione locale. Era la prima volta che la violenza della polizia veniva ripresa e poi diffusa via etere.
Ciò provocò una forte reazione di sdegno in tutta la nazione, che sfociò in una vera e propria rivolta quando – il 29 aprile dell’anno successivo – una giuria, caratterizzata dal non includere neppure un nero fra i suoi componenti, assolse i poliziotti accusati di aver usato una forza eccessiva nei confronti di Rodney King. La rabbia della popolazione nera diede vita a uno scontro di piazza che durò 7 giorni e 7 notti ed ebbe conseguenze devastanti: 64 persone morirono, 2.383 furono ferite, 12.000 furono arrestate e i danni alle proprietà private ammontarono a più di un miliardo di dollari. La rivolta ebbe, tuttavia, anche il positivo effetto di innescare – in un sistema che singolarmente ammette doppi processi sugli stessi fatti nei confronti delle stesse persone, purché effettuati a livelli giurisdizionali, federale o statali, diversi – l’avvio di un procedimento penale federale contro i quattro poliziotti assolti in California. Un anno dopo, due di essi furono infine condannati, sia pure alla sanzione di 30 mesi di carcere, da molti ritenuta eccessivamente lieve ed effettivamente notevolmente ridotta in sede di commisurazione della pena dall’operare di particolari attenuanti riconosciute dal giudice. Era il segnale che le cose assai difficilmente sarebbero cambiate.
La videoregistrazione del pestaggio di Los Angeles aveva portato tanti a credere che l’inconfutabile prova dell’uso di una violenza razzista e ingiustificata da parte della polizia statunitense che ne era derivata avrebbe necessariamente innescato, insieme alla stigmatizzazione sociale dei metodi brutali utilizzati, un cambiamento radicale nel comportamento degli agenti. Quella convinzione però si rivelò ben presto errata, ché anzi – e nonostante le frequenti registrazioni filmate degli abusi perpetrati – non solo la brutalità poliziesca da allora non si è mai arrestata, ma al contrario da “meri” spietati pestaggi è passata vieppiù ad assumere la forma di veri e propri omicidi.
A quasi trent’anni di distanza dall’aggressione degli agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles ai danni di Rodney King, la morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis non è, infatti, che uno dei tantissimi decessi da allora provocati dal comportamento eccessivamente violento delle forze dell’or…