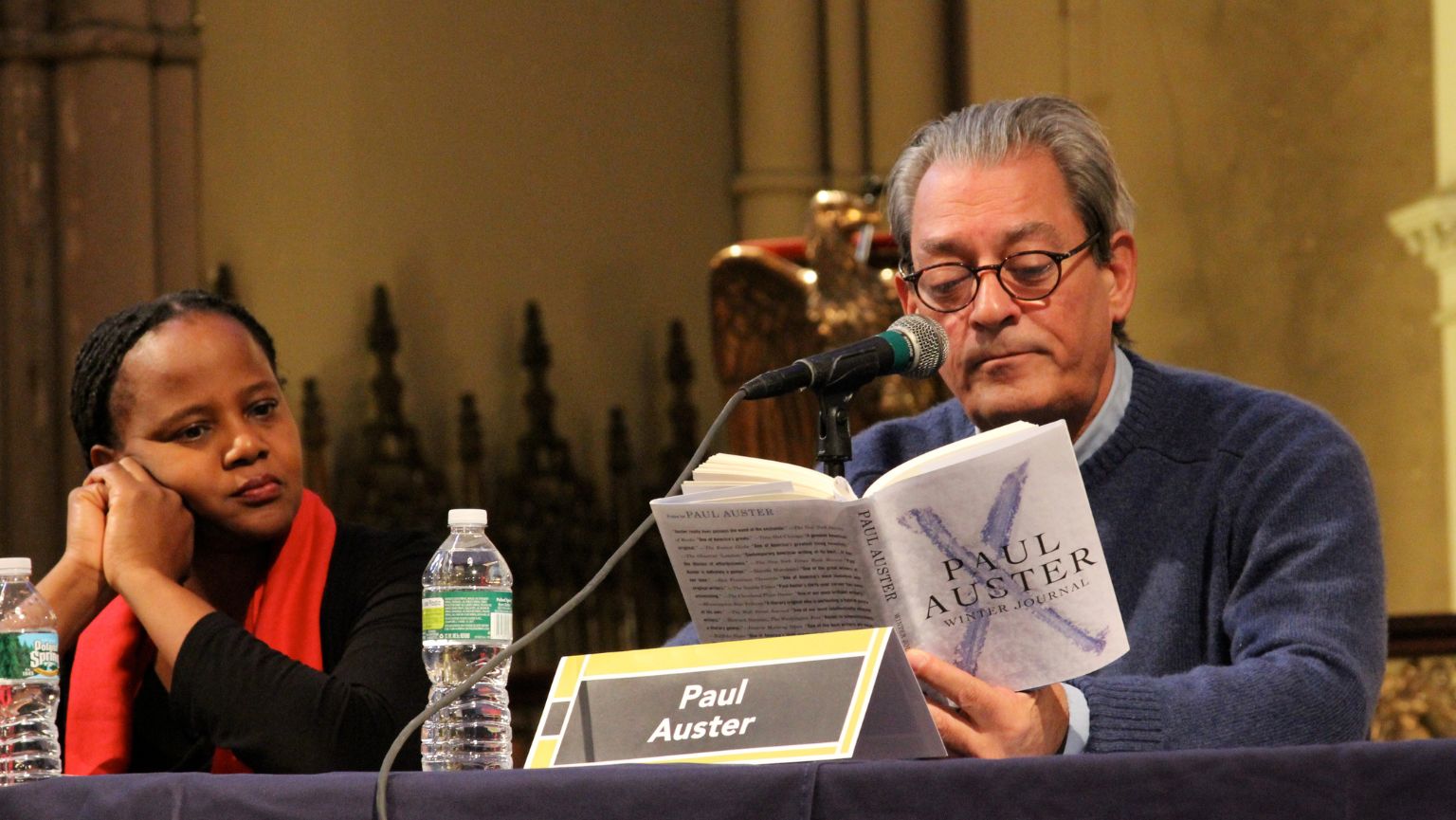Sin dalle prime settimane di guerra in Ucraina, per buona parte della sinistra occidentale le cause scatenanti dell’invasione sono state da ricercarsi nell’ampliamento o addirittura nell’accerchiamento della Russia da parte della NATO, nella protezione delle popolazioni russofone del Donbas, nel progetto di “denazificazione” dell’Ucraina; non veniva riconosciuta alla reazione ucraina la dignità di resistenza. Di contro, altre letture, come quella dell’economista Yuliya Yurchenko, invitano a rifarsi alle lotte di liberazione nazionale in Africa e altrove per capire davvero cosa stesse accadendo.
A distanza di oltre 17 mesi, tutte queste considerazioni sull’espansione della NATO stanno crollando sotto il peso di un’analisi appena più articolata: è vero che Bush Jr nel 2008 aveva auspicato l’entrata dell’Ucraina nell’alleanza, ma Francia e Germania avevano risposto con molta freddezza all’appello. Le stesse truppe americane in Europa sono passate da 315.000 nel 1989 a circa 107.000 nel 1995 fino a ridursi a 60.000 nel 2006, rimanendo stabili da lì in poi, fino al 2021.[1] Anche la dislocazione missilistica della NATO è pressoché stabile da oltre trent’anni, senza contare inoltre il Memorandum di Budapest del 1994 (fortemente caldeggiato dalla dirigenza Usa dell’epoca) con cui l’Ucraina cedette unilateralmente alla Russia il proprio arsenale nucleare. Nel 2019, infine, il presidente francese Emmanuel Macron definì la NATO un peso morto, un organismo “in stato di morte celebrale”. Una lettura più attenta e realistica dovrebbe far accettare il fatto che a partire dall’invasione del 24 febbraio 2022 è stato proprio Putin a rivitalizzarla: l’Ucraina era probabilmente ben lungi dall’entrare nelle NATO ma, soprattutto, Finlandia e Svezia, fino a quel momento, non si sognavano neppure di entrarne a far parte. L’ossigeno offerto alla NATO da Putin è facilmente verificabile anche da altre dirette conseguenze dell’invasione: la firma dell’accordo per la nascita della più grande forza aerea europea con Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia che hanno unito le loro flotte e agiranno in modo unitario, mettendo a fattor comune addestramento, logistica, supporto e pianificazione è il migliore esempio possibile di “boccata d’aria” offerta da Putin; così come la continuità di una governance a trazione europea della NATO stessa, percepita da una buona parte della sinistra come semplice sudditanza nei confronti degli Usa e non come un attuale maggior peso europeo all’interno dell’alleanza. Per quanto riguarda il Donbas, la questione è complessa ma non è argomento centrale di questo scritto anche perché meriterebbe un’ampia trattazione demitizzante [leggere in proposito la terza parte del dossier “Putin. Guerra” raccolto dal dissidente russo Boris Nemcov poco prima di essere assassinato]. Possiamo però ricorrere ancora ai numeri: le vittime civili da entrambe le parti, durante l’anno di guerra aperta 2014 – il più feroce, quello della strage di Odessa – furono 2.084 per calare poi costantemente: nel 2019, anno dell’elezione di Zelens’kyj furono 27; 26 nel 2020 e 25 nel 2021, grazie a un percorso promesso dal neopresidente che avrebbe portato quelle regioni, secondo le intenzioni, ad una condizione di maggior autonomia fino alla prospettiva referendaria: vale la pena ricordare che nelle elezioni presidenziali Zelens’kyj ottenne la maggioranza assoluta anche in Donbas. Una situazione, quindi, tutt’altro che risolta ma fortunatamente ridimensionata almeno in termini di vittime. Una giustificazione dell’invasione che si aggrappa alla difesa dei russi del Donbas può essere credibile tanto quella dell’“aiuto fraterno” nella Praga del 1968.
Anche la questione della “denazificazione” crolla sotto l’evidenza dei dati e magari anche solo sotto il peso di un minimo di onestà intellettuale. Il problema dell’estrema destra in Europa orientale esiste anche se, proprio in Ucraina, in termini elettorali non ha avuto particolare rilevanza. Detto questo, e sempre per rimanere ai dati, il Paese “denazificatore”, la Russia, è quello che se la passa peggio di tutti: nel 2018 un importante studio di Johannes Due Enstad, Right-Wing Terrorism and Violence in Putin’s Russia, evidenziava che il livello di violenza omicida dell’estrema destra russa era superiore del 750% rispetto a quello dell’estrema destra in Europa Occidentale, del 500% rispetto a quella negli Usa, nonché quattro volte …