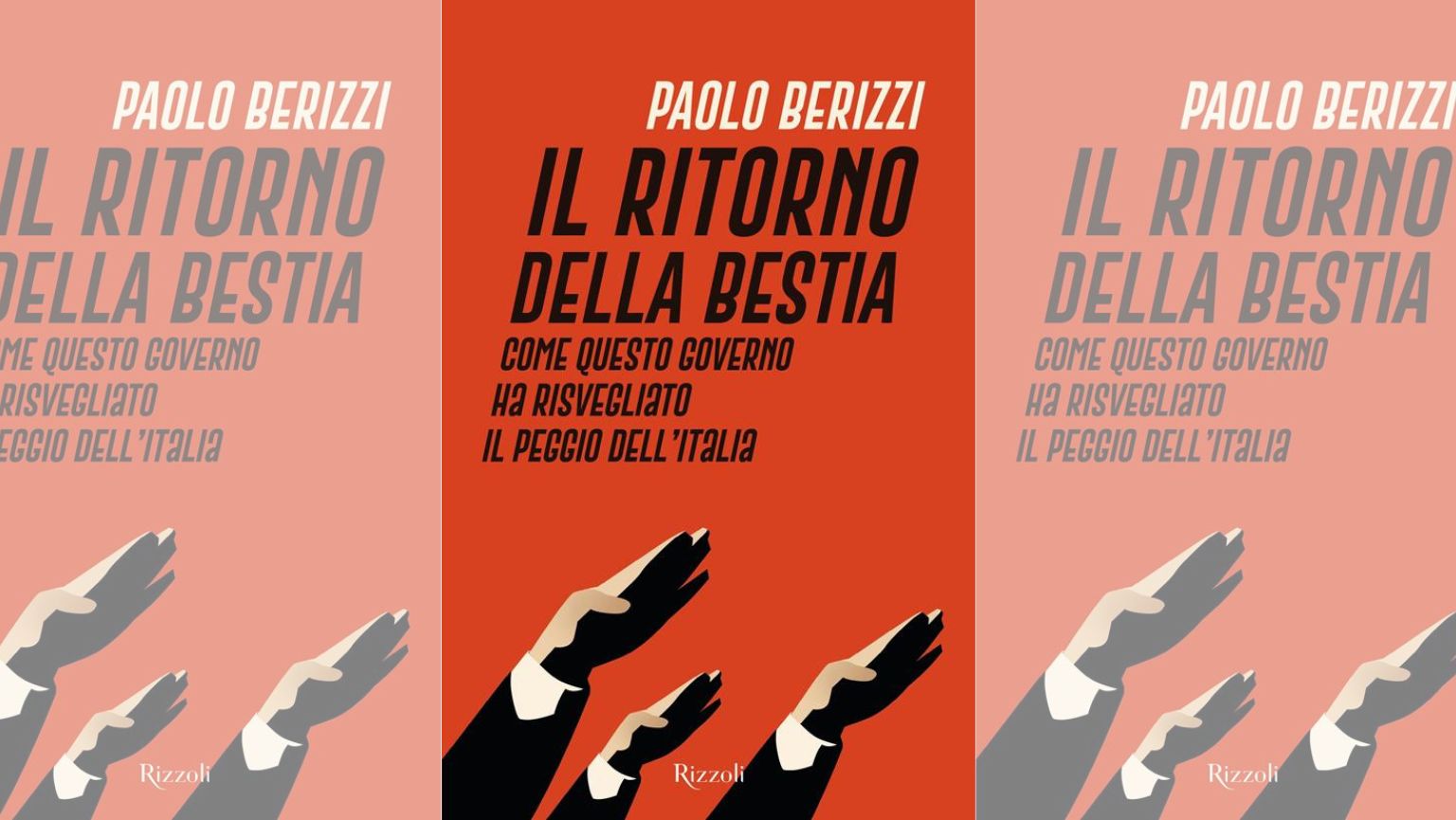Il report “La sfida dell’efficienza energetica alla prova delle disuguaglianze” riguardante le politiche sull’energia, reso noto il 15 luglio scorso dal Forum Disuguaglianze e Diversità, contiene una serie di riflessioni condivisibili e basate su un’analisi economica attenta e pertinente. Tra gli elementi che ci appaiono più illuminanti, va annoverato il disvelamento della regressività delle misure attuate negli ultimi 15 anni per favorire ciò che oggi si chiama transizione energetica. In altre parole, è chiaramente scritto nel documento, tali politiche non hanno avuto alcun approccio redistributivo, cioè a vantaggio delle fasce di popolazione meno abbienti, ma, anzi, il loro carattere distributivo ha finito con il favorire soprattutto le fasce economicamente più forti. In questo senso vengono definite regressive. Tuttavia la questione è affrontata dal punto di vista delle diseguaglianze dei redditi; tuttavia, ancora più incisive – a maggior ragione sulla base di quanto stiamo vedendo accadere in Sicilia, nell’estate del 2023 – ci pare il tema delle diseguaglianze territoriali, se non altro perché la sempre più accentuata divisione – se non spaccatura – del Paese tra aree ricche e aree povere, tra comunità che godono dei diritti e quelle che ne sono private è l’elemento che, più di ogni altro, mina dalle fondamenta la credibilità, se non la sopravvivenza, della Repubblica come è stata costruita a partire dalla Resistenza.
Quello che ci sembra necessario tenere in considerazione è ciò che proveremo a chiamare “regressività territoriale”, in altre parole quel continuo drenaggio di risorse dalle aree deboli verso quelle forti che va avanti in Italia senza soluzione di continuità da oltre 150 anni, con alcune fasi eccezionali come il periodo 1950-1970 che corrisponde alla prima fase della cassa per il Mezzogiorno. Un drenaggio che oggi sposta prima di tutto la risorsa più rara e preziosa, quella umana, come dimostra il dato che lo Svimez ha pubblicato negli stessi giorni.
Secondo quest’ultimo, tra il 2001 e il 2021 460.000 laureati si sono trasferiti dal sud al nord e di questi, circa un terzo, hanno un titolo di studio STEM, cioè in discipline scientifico-tecnologiche. Nell’analisi non sono contemplati i laureati che sono andati all’estero, contribuendo in maniera decisiva alla triste bilancia che vede andare via giovani con elevate capacità e arrivare dai paesi meno sviluppati (peraltro con l’obiettivo di andarsene altrove in Europa) giovani con competenze prevalentemente generiche e di basso profilo. Un fenomeno talmente rilevante che la Sicilia, al primo posto nella classifica regionale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire), registra nel 2020 quasi 785.000 iscritti, un numero ben superiore agli abitanti di Palermo, la prima città dell’isola.
Questi dati confermano non solo che persistono nel Paese le diseguaglianze territoriali, ma che esse si sono accentuate nei primi decenni del Ventunesimo secolo. Prendere atto di questa realtà può condurre ad accettarla o accentuarla oppure a individuare percorsi per ridurre queste diseguaglianze. Crediamo che anche le politiche sull’improrogabile efficientamento energetico dell’immenso parco edilizio nazionale non possono essere neutrali rispetto a questa questione che è centrale per il futuro del Paese. Per questo un piano di così grande portata come quello auspicato a livello europeo e oggetto delle analisi contenute nel report dovrebbe essere riformulato introducendo azioni mirate al riequilibrio territoriale, un tema che non riguarda solo il nostro Paese e che ha visto l’avvio di politiche specifiche in nazioni come il Regno Unito, dove il termine levelling up è entrato a far parte del nome del Ministero che si occupa delle comunità locali e delle politiche della casa e che è impegnato nella realizzaz…