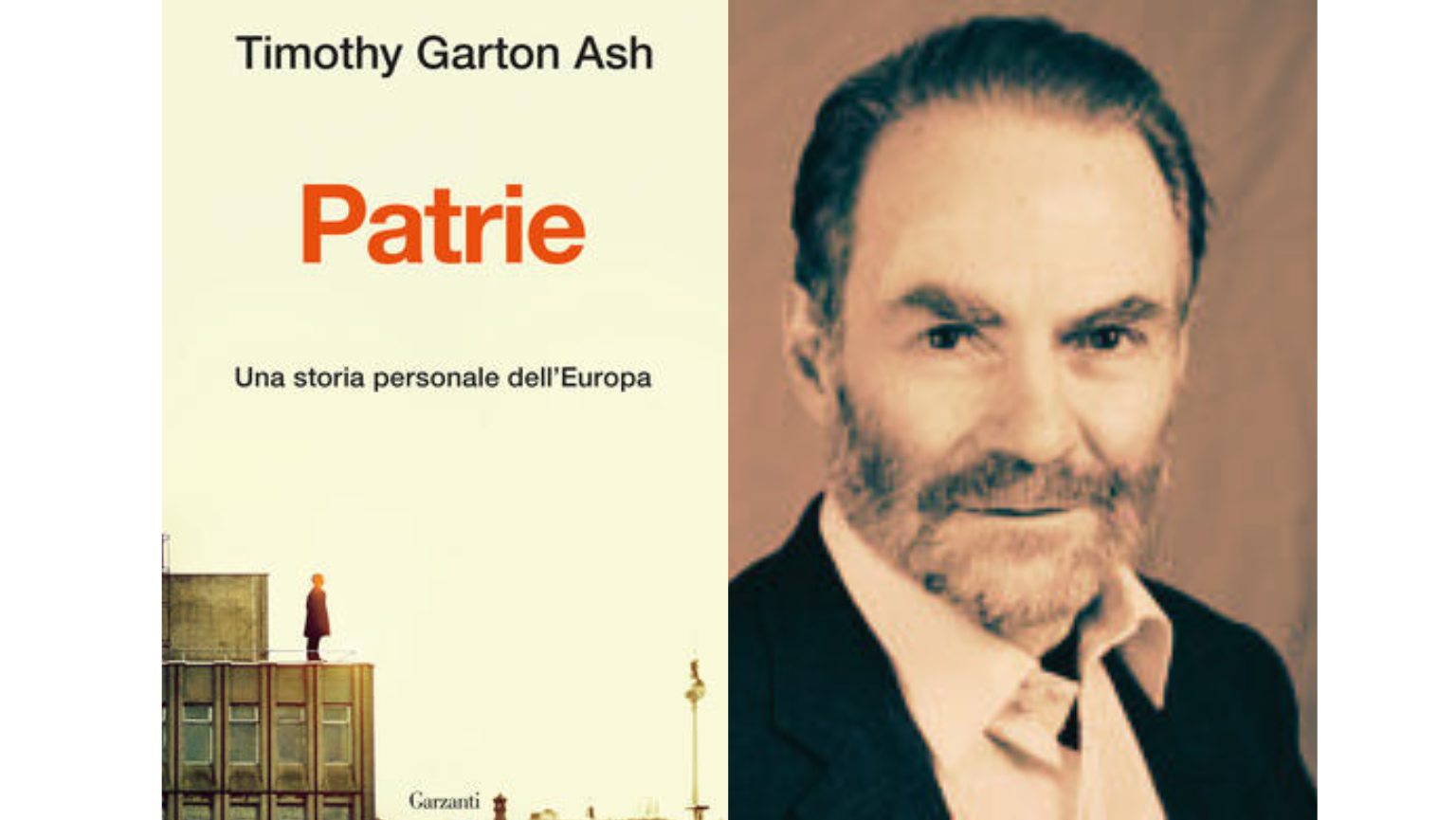Comincerei da una considerazione che lei fa alla fine del suo libro, in cui afferma che l’Europa di oggi è nel complesso migliore della vita in Europa nel post Seconda guerra mondiale e negli anni Settanta del Novecento, quando lei, all’epoca un giovane Timothy Garton Ash curioso del mondo, diede inizio ai suoi viaggi che l’hanno portata poi a essere un convinto amante dell’Europa. Tuttavia, come lei stesso scrive, fra quelle epoche e l’oggi ci sono stati periodi, come per esempio i primissimi anni Novanta, in cui nel complesso i cittadini europei si sentivano più ottimisti e percepivano nella loro vita maggiore benessere rispetto a oggi. Basti pensare agli indici economici, nel caso dell’Italia impietosi: siamo l’unico Paese che percepisce un reddito inferiore rispetto al 1991. Forse l’affermazione che oggi in Europa si vive meglio andrebbe dunque ulteriormente relativizzata?
Sì, questo è il punto più critico che sottolineo nel libro, in quelle che ho definito come le diverse “postwar” vissute in Europa a cominciare da quella che segue la Seconda guerra mondiale. Se pensiamo all’Europa meridionale in particolare, se pensiamo a un giovane spagnolo, portoghese, greco, o italiano, tutti loro hanno buona ragione di ritenere che nei primi anni 2000 la vita in Europa fosse migliore di quella di oggi. La crisi finanziaria globale, la recessione delle ricchezze individuali, la crisi del debito e il livello di consapevolezza dell’ineguaglianza e della mancanza di opportunità nella vita, tutto questo rappresesenta uno dei cuori del problema. L’argomento in favore dell’Europa, durante i principali “postwar” compreso quello dell’Europa dell’est, era stato alla radice sempre lo stesso: abbiamo vissuto male, a causa di guerre e dittature, e ora vogliamo un luogo migliore in cui vivere, e quel luogo era l’Europa. Ma per un giovane italiano, greco, spagnolo, vale piuttosto l’argomento contrario. Abbiamo vissuto in luoghi migliori, e ora la nostra vita è peggiore di quella di prima, e una parte almeno della responsabilità di questo peggioramento risiede nell’Europa stessa. Non dico con questo che abbiano ragione, non sono sicuro che abbiano ragione. Ma questo sentimento è diffuso e bisogna farci i conti. Non esiste un modo unico di guardare all’Europa, che ci può apparire migliore o peggiore di un tempo a seconda di chi la guarda, di dove si posiziona chi pensa all’Europa. In questo momento, pensando alla gioventù dei vari Paesi europei, assistiamo ad alcuni fenomeni preoccupanti. Ci piace pensare che le giovani generazioni siano le più europeiste fra noi, ma questo non è necessariamente vero. In Polonia, dove si terranno importanti elezioni politiche fra una decina di giorni, molti giovani si ritrovano nelle posizioni di Confederazione Libertà e Indipendenza (Konfederacja), un partito fortemente euroscettico, nazionalista e contrario al sostegno alla resistenza ucraina.
Sembra che molti equivoci, differenze di pensiero e necessità di sciogliere i significati, nell’Europa di questi anni, ruotino attorno al concetto di “sovranità”. L’impressione è che rappresenti un concetto molto ambiguo, non affrontato in modo trasparente. Il concetto di sovranità da un certo punto di vista rappresenta la base stessa, la prima fondazione, delle democrazie liberali del dopoguerra: l’Italia, nel primo articolo della sua Costituzione, si statuisce come Repubblica sovrana. O pensiamo alla centralità che riveste, per il popolo ucraino, oggi, la difesa della propria sovranità. Allo stesso tempo, la sovranità viene usata in chiave antidemocratica, illiberale, pensiamo a tutte le correnti e compagini europee che abbiamo definito “sovraniste” e che riteniamo in qualche forma stiano rappresentando una minaccia per la democrazia. Come facciamo i conti con il concetto di sovranità?
Da un certo punto di vista, mi ritrovo spesso a pensare che sarebbe meglio se non usassimo pi…