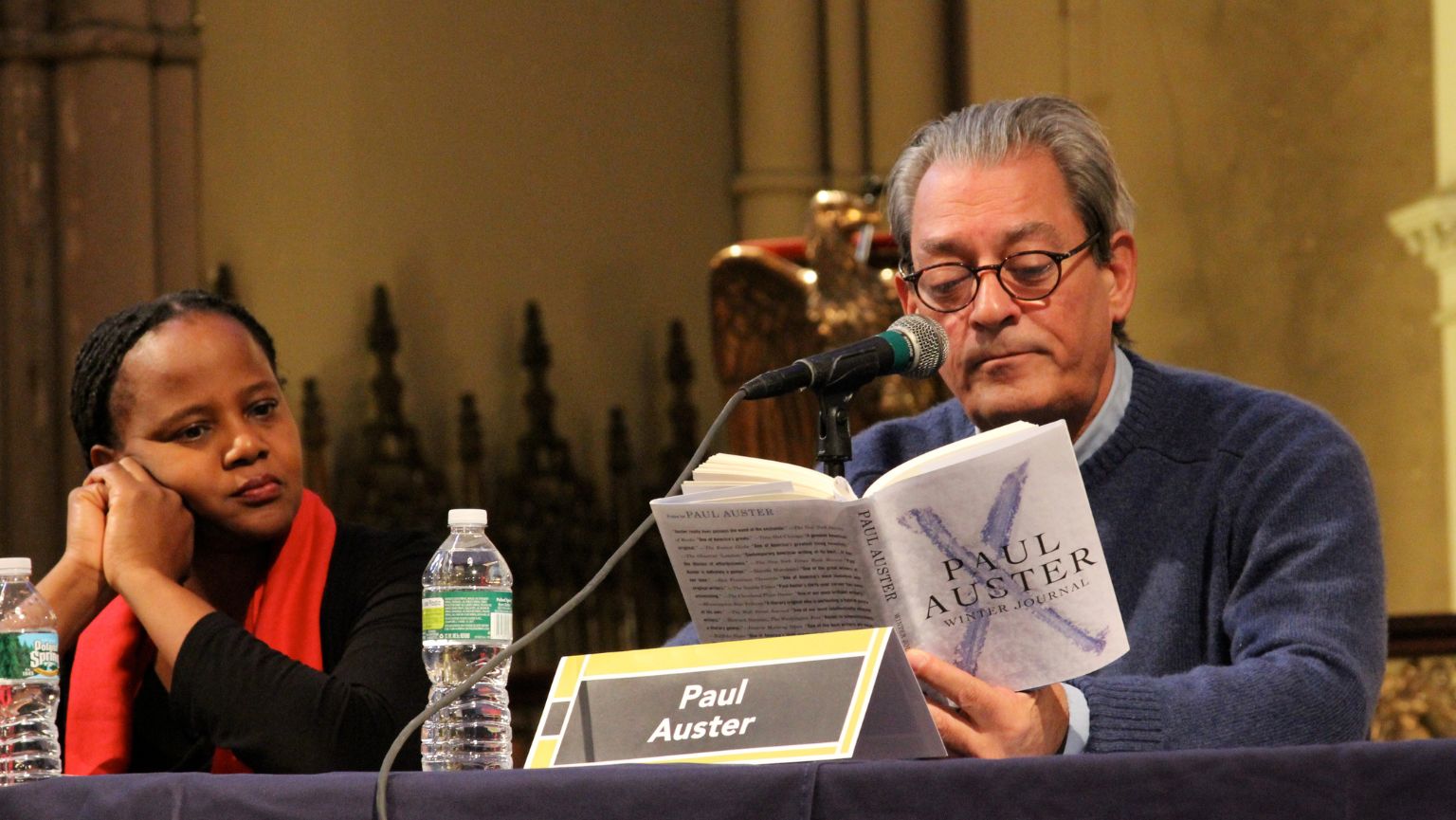In quanti modi ci si può scusare? Il re Carlo d’Inghilterra ne avrà vagliati molti, prima di volare in Kenya il mese scorso. E alla fine ha scelto la prudenza. Nessuna scusa formale, ma “grande dolore e profondo rimpianto” per quanto accaduto in epoca coloniale. Frettoloso, diplomatico, poco convincente. Così è stato recepito dai keniani, le cui ferite sono ancora aperte.
Sono passati esattamente sessant’anni dalla fine della dominazione, da quello scoccare della mezzanotte, tra l’11 e il 12 dicembre 1963. Nel grande stadio appena inaugurato, veniva eseguito per la prima volta l’inno nazionale del Kenya e la nuova bandiera prendeva il posto dell’Union Jack, lasciata scivolare a terra. Nairobi esplodeva in atmosfera di giubilo. Auto in coda bloccavano la città, nell’urlo senza fine dei clacson. Il Kenya aveva ottenuto l’indipendenza. Stato sovrano, libero. Dodici mesi dopo, il grande Paese dell’Est Africa diventerà una repubblica presidenziale, parte del Commonwealth.
Da allora, ogni anno, il Kenya festeggia il Jamhuri Day (jamhuri significa repubblica, in swhaili). I giovani inondano i profili social di messaggi di auguri, condividono meme festosi sugli stati di Whatsapp e proclami patriottici su X. Nelle case si preparano piatti regionali come le samosa o l’ugali (sorta di polenta di mais accompagnata da carne, pesce o verdure), si balla, si alzano calici di birra. Qualcuno approfitta per occuparsi delle decorazioni natalizie, qualcun altro assiste alla pompa delle manifestazioni ufficiali, come la (molto inglese) Trooping of the colors.
I più anziani, invece, guardano al passato. Se lo portano addosso, quel passato funesto; cicatrice di una tra le più cupe esperienze della storia imperiale britannica. Il cui epilogo legale è arrivato solo dieci anni fa.
Tutto iniziò nel 1890, quando la regione, dopo un periodo di dominazione tedesca, divenne parte del Protettorato Britannico dell’Africa Orientale, poi colonia nel 1920. Fin da subito, la fertilità del suolo andò in cima agli interessi inglesi. Insediatisi negli altipiani interni dal clima mite – le White Highlands – decretarono che tutte le terre appartenevano alla Corona e che solo i diritti di proprietà individuale venivano garantiti ai nativi. Nel mondo keniano, dove vigeva il possesso consuetudinario e i beni erano gestiti da comunità (anche di centinaia di persone, mescolate e sovrapposte da rapporti di parentela), questo decreto significava un’alienazione forzata dei fondi. I contadini locali, espropriati dei loro campi, vennero impiegati come manodopera a basso costo nelle vaste piantagioni di tè e caffè. Molti furono spinti nelle “riserve native”, create nel 1904. Il risultato fu che, già nel 1934, i 30mila coloni bianchi, pari allo 0,25% della popolazione, controllavano un terzo delle terre coltivab…