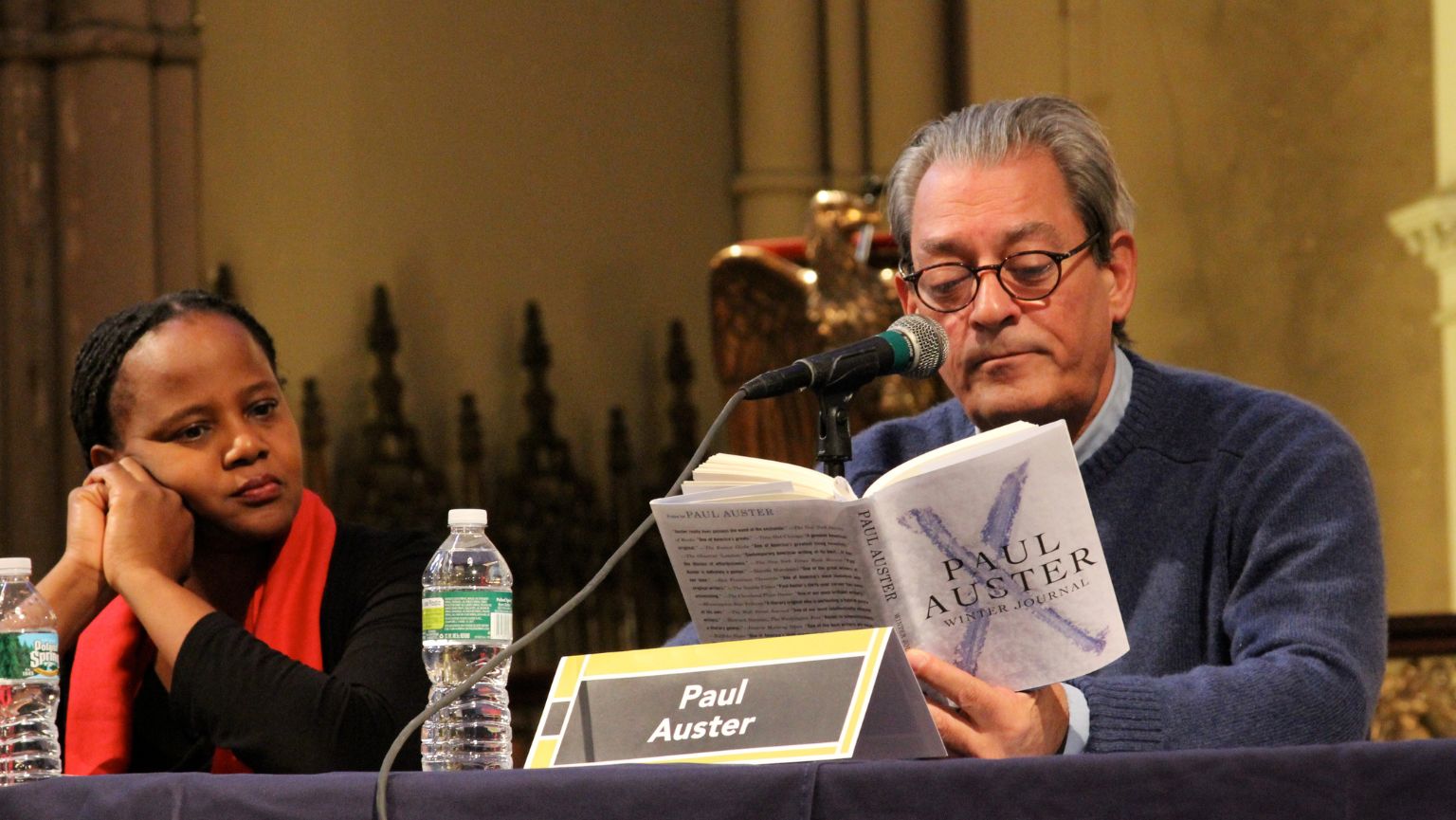Il caso delle donne yazide è stato discusso poco in questi anni, nonostante il conferimento del Nobel per la Pace alla sopravvissuta e attivista Nadia Murad Basee Taha nel 2018. La vicenda di violenza che le riguarda è forse la più emblematica, per quel che riguarda quest’inizio di millennio. Molto ci sarebbe da dire sul silenzio che l’accompagna, ma ciò esula dai limiti di questo articolo. Mi limiterò a un breve spunto di riflessione: la facilità con cui il nostro tempo dimentica – o semplicemente ignora – crimini della portata di un genocidio (quello contro gli yazidi iniziato nel 2014) o di una pulizia etnica (quella contro gli armeni del Karabakh, avvenuta quest’anno) è uno dei punti più inquietanti per chi si interroghi, cercando di intravederne gli esiti, sul futuro che ci attende.
Tornando al nostro discorso, non mancano abbondanza di prove raccolte e studi sul genocidio contro questa minoranza religiosa, come sulla violenza contro bambine, ragazze e donne yazide, che rappresenta una pagina fondamentale di questa tragedia. UNITAD, il team investigativo delle Nazioni Unite per i crimini commessi da Daesh, dove ha lavorato anche Karim Khan, l’attuale procuratore capo della Corte Penale Internazionale, ha pubblicato il 3 dicembre un importante report sul tema dal titolo Report on sexual violence against women and girls committed by ISIL in Iraq. Nonostante rientri in una cornice più ampia, quella appunto della violenza contro ragazze e donne in Iraq sotto l’occupazione dell’autoproclamato Stato Islamico, tratta con attenzione il tema del genocidio, dalle pseudo-giustificazioni teologiche alla violenza sessuale, fino all’impatto psicologico e sociale di quest’arma di guerra che continua a segnare il destino di moltissime vite.
Precisiamo subito che la definizione di genocidio per quel che riguarda gli yazidi è ormai assodata da un punto di vista internazionale come anche nella letteratura scientifica (così anche ne Il genocidio di Marcello Flores, edito nel 2021). Oltre all’ONU, risoluzioni che lo definiscono come tale si sono avute dal Bundestag al Senato francese, dagli Usa al Regno Unito passando per il Parlamento italiano. È importante ricordarlo, dato il continuo abuso del termine al di fuori della cornice giuridica e storica che gli compete fin dalla sua definizione ad opera del giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, poi accolta dalle Nazioni Unite. Perché no, genocidio non significa affatto un grande massacro. Per non parlare del fatto che il termine viene usato per costruire veri e propri obbrobri propagandistici, come quando l’attuale Ministro dei trasporti italiano Matteo Salvini parlò di un presunto “genocidio contro gli italiani” ad opera dei migranti.
…