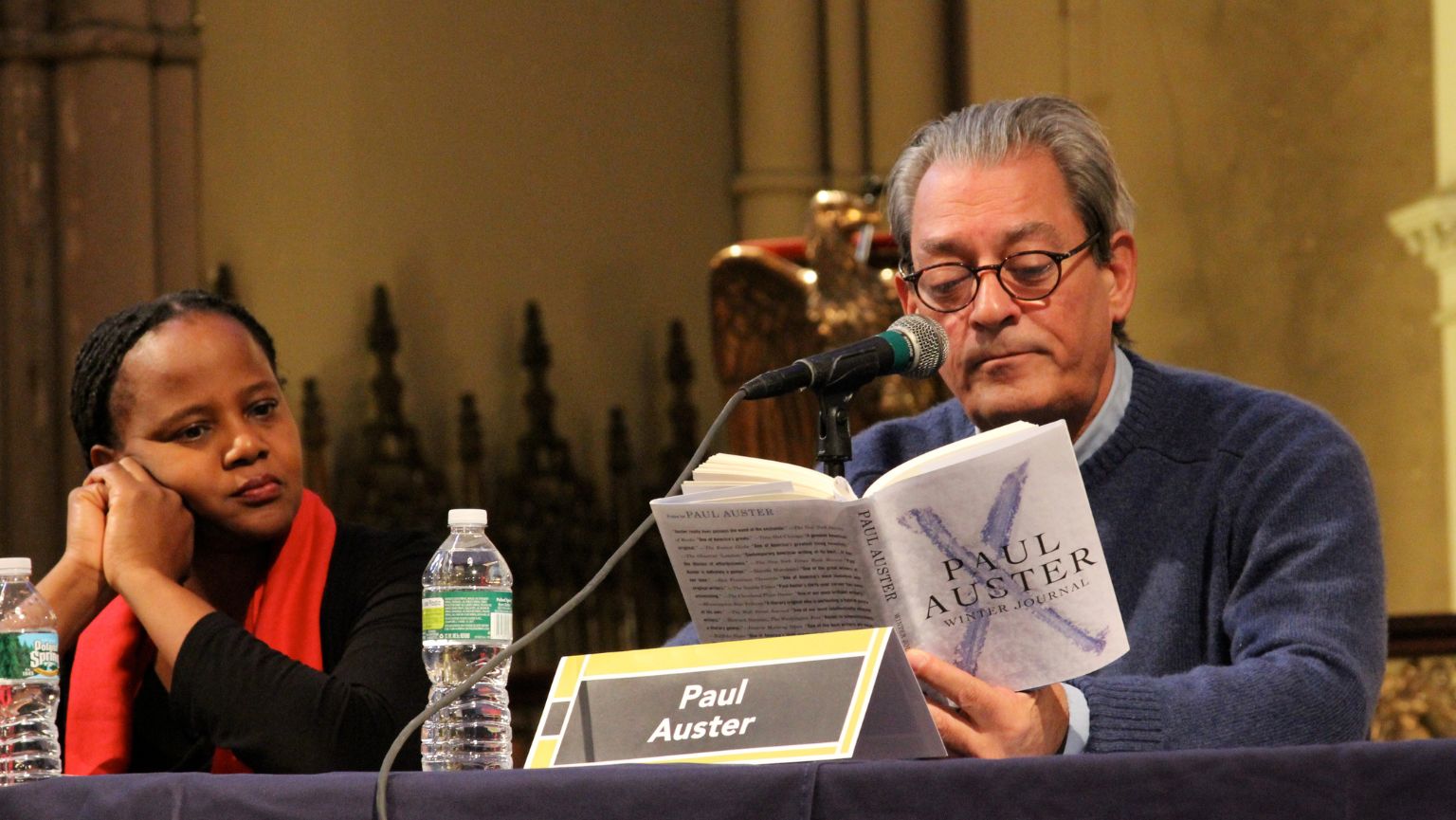Il percorso che va dall’ideazione di un personaggio secondario di una serie televisiva all’esposizione di un suo elemento identificativo al Museo nazionale di storia americana di Washington, e all’edificazione di una statua in suo onore nella cittadina in cui quella serie è ambientata, è temporalmente breve e concettualmente lungo. Temporalmente breve perché la scalata ai vertici del gradimento degli spettatori americani del personaggio in questione, Arthur Herbert Fonzarelli (Henry Winkler), meglio conosciuto come Fonzie o The Fonz, star della sitcom Happy Days, è stata fulminante; concettualmente lungo perché attraverso quel personaggio e il mondo finzionale in cui si muove, gli americani hanno più o meno consapevolmente riflettuto sull’idea che avevano di sé stessi e su ciò che volevano essere in un periodo complicato della loro storia recente.
Eternare l’american way of life
Il primo episodio di Happy Days è andato in onda cinquant’anni fa, il 15 gennaio 1974, quando la guerra del Vietnam aveva ormai già da tempo decretato la perdita dell’innocenza americana. Usciti dalla Seconda guerra mondiale come assoluti trionfatori e nazione leader del cosiddetto mondo libero, gli americani avevano cullato l’illusione di essere davvero il Paese collocato sempre dalla parte giusta della storia, la terra della libertà per i cui valori e per il cui stile di vita valesse la pena vivere e morire. Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki potevano essere giustificate dalla necessità di porre fine al conflitto mondiale mentre la guerra di Corea, seppur causa di numerose perdite, era comunque stata combattuta dagli Stati Uniti su mandato del Consiglio di sicurezza dell’ONU. La guerra del Vietnam, che invece costò un gran dispendio di risorse e una ingente perdita di vite umane, combattuta per ragioni poco comprensibili e difficilmente giustificabili e che si sarebbe per giunta conclusa con una ritirata ingloriosa, non poteva essere in alcun modo inclusa nell’alveo del sogno americano, che anzi scalfì, in modo profondo e doloroso. Ecco allora che gli americani, quasi per un’istintiva forma di protezione, iniziarono a guardare al loro passato prossimo anche attraverso la cultura pop, come aveva già testimoniato il successo di un film come American Graffiti di George Lucas: tra gli interpreti, Ron Howard, futuro Richie Cunningham in Happy Days che di lì a poco arriverà sugli schermi delle TV statunitensi.
Le vicende di Happy Days infatti si collocano temporalmente proprio tra la metà degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, dopo la guerra di Corea e prima della guerra del Vietnam, quasi a voler dar vita a una bolla a-temporale in grado di eternare un periodo della storia recente percepito invece come felice e desiderabile. L’America del rock & roll, di cui la colonna della serie costituisce un mirabile compendio, quella della gioventù finalmente libera ma non troppo ribelle e scapestrata, che può sì incontrarsi e divertirsi nei drive-in e nei diner ma che vive ancora con i genitori, di cui non mette ancora in discussione l’autorità, e che non sperimenta il sesso con troppa disinvoltura. Un’America che si colloca quindi non solo prima della guerra del Vietnam ma anche prima della contestazione che quella stessa guerra contribuì ad acuire. Un’America conservatrice, al riparo dal discorso di auto-critica e decostruzione del sogno americano portato avanti dalle sue component…