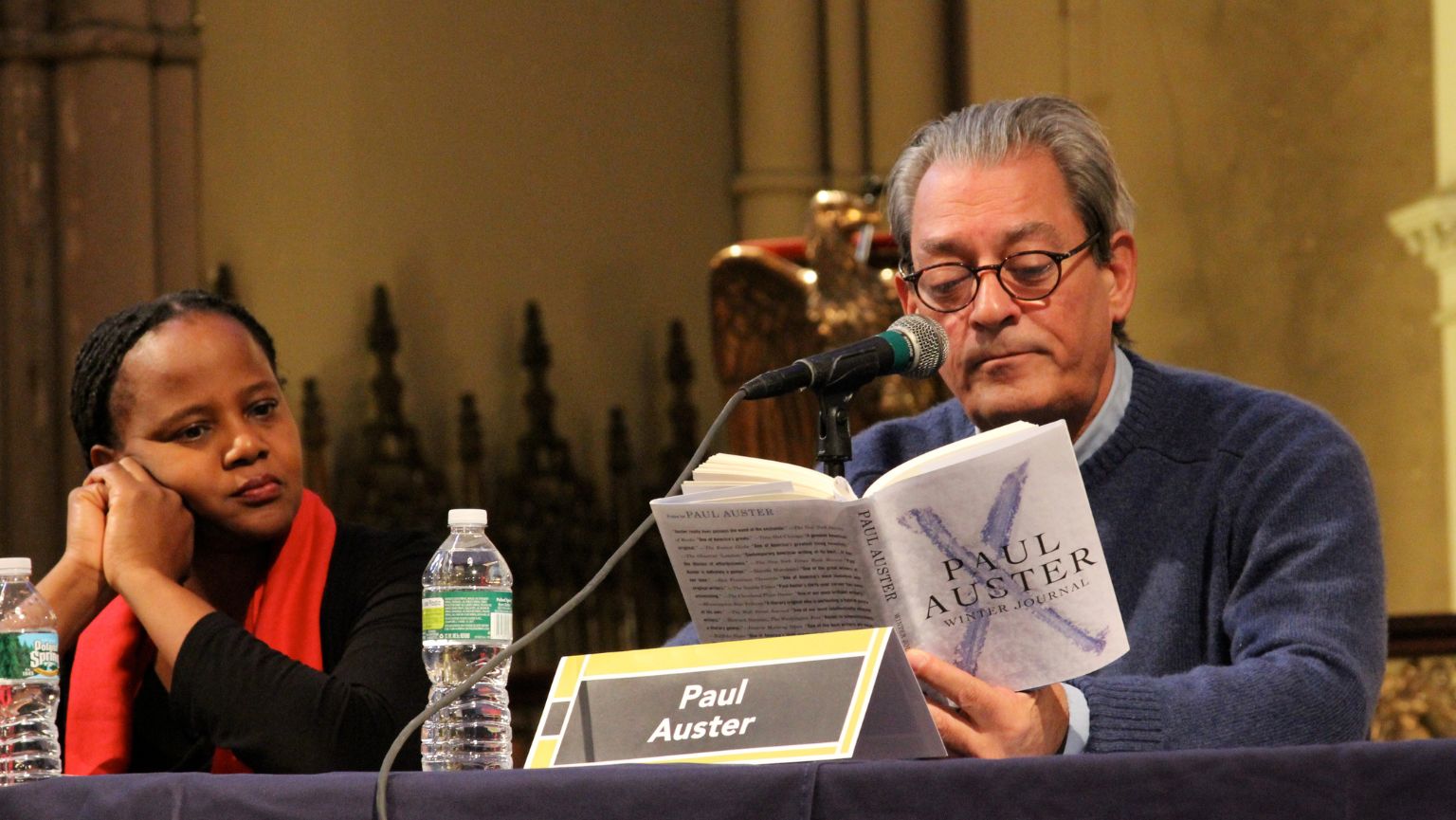Gli Stati Uniti, negli anni ’70, erano al culmine di un periodo di straordinario progresso sociale e civile, che aveva visto la vittoria delle lotte per i diritti delle minoranze e dei più deboli. Si stava per chiudere l’epoca del trentennio glorioso, coincidente con il cosiddetto periodo della prosperità condivisa, frutto di quelle politiche redistributive che avevano accorciato le distanze fra i ricchi e i poveri e dato anche agli ultimi la speranza di una mobilità sociale. Erano gli Stati Uniti in cui meno di un decennio prima Lyndon Johnson, nel varare una serie di misure a favore dei più deboli (come i buoni pasto per gli indigenti, l’assistenza sanitaria gratuita per i più poveri o quella calmierata per gli anziani) affermava come fosse finalmente giunta l’epoca in cui ci si sarebbe potuti liberare dal bisogno. Era una società, quella statunitense del tempo, in cui la speranza di vivere in un mondo sempre più giusto ed equo trovava linfa e sostegno nelle politiche concrete dell’amministrazione a favore dell’inclusione e nei riscontri di un PIL il cui incremento si distribuiva grandemente sulla parte bassa della popolazione. Si trattava di un paese che, grazie anche alla sua Corte Suprema, aveva da poco preso le distanze da un passato di vergognose discriminazioni e in cui le lotte di chi era morto per la causa (Martin Luther King, Malcom X) sembravano infine aver avuto la meglio. Fresco era per esempio il ricordo di Brown v. Board of Education, la famosa decisione del 1953 con cui Earl Warren (già governatore repubblicano della California, poi nominato Chief Justice della Corte Suprema dal presidente conservatore Eisenhower) aveva portato una SCOTUS (Supreme Court of United States) unanime a rovesciare il precedente (Plessy v. Ferguson) che imponeva la segregazione dei bambini neri nelle scuole, costringendo il presidente Eisenhower a inviare le truppe federali per sedare i malumori dei governatori, che – come in Alabama, Arkansas o Mississippi – non volevano rispettare quella pronuncia. L’inizio degli anni ’70 rappresentava, insomma, un momento storico di grande fermento, carico di energia positiva e speranza. È in un tale contesto che la decisione Roe v. Wade fu concepita.
Il caso che nel 1971 si presentava alla Corte Suprema era quello di Norma McCorvey (alias Jane Roe), donna venticinquenne – con già due gravidanze alle spalle, culminate in entrambi i casi in genitorialità adottive – che alla terza gravidanza avrebbe voluto abortire. Dopo aver contemplato l’ipotesi di presentare la sua gestazione come il frutto di uno stupro, nella speranza di aggirare le strette maglie della legge texana che puniva il procurato aborto salvo nel caso in cui si trattasse di salvare la vita della donna, Norma si rivolse a due avvocatesse. Le professioniste iniziarono una class action contro Henry Wade – il District Attorney di Dallas che avrebbe dovuto dare applicazione alla normativa antiaborto contro i dottori che lo avessero realizzato – domandando che la legge fosse dichiarata incostituzionale e al District Attorney fosse ingiunto di non proceder…